LIBRO SECONDO
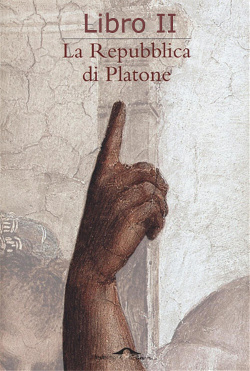 Dopo aver detto questo io credevo di essermi sbrigato dalla discussione; ma quello, a quanto pare, era soltanto il proemio. Infatti Glaucone, che in ogni circostanza è sempre il più combattivo, anche in quel caso non accettò la rinuncia di Trasimaco, ma disse: «Socrate, vuoi dare l'impressione di averci persuasi, o vuoi veramente persuaderci che il giusto è in ogni modo migliore dell'ingiusto?» «Se dipendesse da me», risposi, «preferirei persuadervi davvero».
Dopo aver detto questo io credevo di essermi sbrigato dalla discussione; ma quello, a quanto pare, era soltanto il proemio. Infatti Glaucone, che in ogni circostanza è sempre il più combattivo, anche in quel caso non accettò la rinuncia di Trasimaco, ma disse: «Socrate, vuoi dare l'impressione di averci persuasi, o vuoi veramente persuaderci che il giusto è in ogni modo migliore dell'ingiusto?» «Se dipendesse da me», risposi, «preferirei persuadervi davvero».
«Allora non raggiungi il tuo scopo», ribatté. «Dimmi un po': ti sembra che esista un bene tale che potremmo accettarlo non per il desiderio dei vantaggi che ne derivano, ma perché ci è caro per se stesso, come la gioia e tutti i piaceri che non arrecano danno e che per il tempo a venire non comportano altro che il godimento del loro possesso?» A me sembra che qualcosa del genere esista», risposi.
«E che dire allora di quel bene che amiamo per se stesso e per ciò che ne deriva, come possedere l'intelligenza, la vista e la buona salute? Beni di questo genere li apprezziamo per entrambe le ragioni». «Sì », dissi.
«E riconosci», proseguì , «una terza specie di beni, di cui fanno parte la ginnastica, la guarigione da una malattia, l'esercizio della medicina e le altre professioni redditizie? Potremmo dire che queste attività sono faticose ma ci danno giovamento, e non accetteremmo di possederle per se stesse, ma per il compenso e per tutti gli altri vantaggi che ne derivano». «Sì », dissi, «esiste anche questa terza specie. E allora?» «In quale di esse collochi la giustizia?», chiese. «Nella migliore, credo», dissi, «quella che chi vuole essere beato deve apprezzare sia per se stessa sia per ciò che ne deriva».
«Tuttavia la gente non la pensa così », ribatté, «ma colloca la giustizia nella specie dei beni che costano fatica e si
devono coltivare per i compensi e la buona fama che procurano, ma si devono fuggire per se stessi in quanto molesti».
«Lo so», dissi, «che la gente la pensa così e già da un pezzo Trasimaco biasima la giustizia in quanto tale, e loda
l'ingiustizia; ma io, a quanto pare, sono duro di comprendonio».
«Via», disse, «ascolta anche me, per vedere se resti ancora della tua opinione. Mi sembra che Trasimaco sia stato
incantato da te troppo presto, come un serpente, e la dimostrazione dei concetti di giustizia e ingiustizia non mi ha ancora
convinto; desidero infatti ascoltare che cos'è l'una e l'altra cosa, e quale forza possiedono di per sé quando agiscono
sull'anima, lasciando perdere i compensi e ciò che ne deriva. Farò dunque così , se anche tu sei d'accordo: rinnoverò il
discorso di Trasimaco, e innanzitutto esporrò l'opinione comune sulla giustizia e sulla sua origine; in secondo luogo dirò
che tutti coloro che la praticano lo fanno contro voglia, come una necessità e non come un bene, in terzo luogo che la loro
condotta è ragionevole, perché secondo loro la vita dell'ingiusto è di gran lunga migliore di quella del giusto. Io però,
Socrate, non sono di questo avviso: tuttavia mi trovo nel dubbio, perché ho le orecchie rintronate dai discorsi di
Trasimaco e di tantissime altre persone, ma non ho ancora sentito nessuno esporre nel modo in cui voglio la tesi che la
giustizia è migliore dell'ingiustizia; io voglio sentirla elogiare per se stessa, e mi aspetto questo discorso soprattutto da te.
Pertanto mi sforzerò di tessere le lodi della vita ingiusta, e con le mie parole ti mostrerò come voglio sentirti biasimare a
tua volta l'ingiustizia ed elogiare la giustizia. Vedi dunque se la mia proposta ti piace».
«Più d'ogni altra!», risposi. «Su quale argomento una persona assennata potrebbe aver piacere di parlare e ascoltare
più spesso?» «Molto bene», disse. «Ascolta ora il primo argomento che avevo preannunciato, ovvero che cos'è la giustizia
e da dove nasce.
Si dice che il commettere ingiustizia sia per natura un bene, il subirla un male, e che il subirla sia un male maggiore di
quanto non sia un bene commetterla; di conseguenza, quando gli uomini commettono ingiustizie reciproche e provano
entrambe le condizioni, non potendo evitare l'una e a scegliere l'altra sembra loro vantaggioso accordarsi per non
commettere né subire ingiustizia. Di qui cominciarono a stabilire leggi e patti tra loro e a dare a ciò che viene imposto
dalla legge il nome di legittimo e di giusto. Questa è l'origine e l'essenza della giustizia, che sta a metà tra la condizione
migliore, quella di chi non paga il fio delle ingiustizie commesse, e la condizione peggiore, quella di chi non può
vendicarsi delle ingiustizie subite. Ma la giustizia, essendo in una posizione intermedia tra questi due estremi, viene amata
non come un bene, ma come un qualcosa che è tenuto in conto per l'incapacità di commettere ingiustizia; chi infatti
potesse agire così e fosse un vero uomo, non si accorderebbe mai con qualcuno per non commettere o subire ingiustizia,
perché sarebbe pazzo.
Tale, Socrate, è dunque la natura e l'origine della giustizia, secondo l'opinione corrente».
«Ci renderemmo conto perfettamente che anche chi la pratica lo fa contro voglia, per l'impossibilità di commettere
ingiustizia, se immaginassimo una prova come questa: dare a ciascuno dei due, al giusto e all'ingiusto, la facoltà di fare
ciò che vuole, e poi seguirli osservando dove li condurrà il loro desiderio. Allora coglieremmo sul fatto il giusto a battere
la stessa strada dell'ingiusto per spirito di soperchieria, cosa che ogni natura è portata a perseguire come un bene, mentre
la legge la devia a forza a onorare l'uguaglianza.
E la facoltà di cui parlo sarebbe tale soprattutto se avessero il potere che viene attribuito a Gige, l'antenato di Creso re
di Lidia.(1) Si racconta che egli serviva come pastore l'allora sovrano di Lidia. Un giorno, a causa delle forti piogge e di
un terremoto, la terra si spaccò e si produsse una fenditura nel luogo in cui teneva il gregge al pascolo. Gige si meravigliò
al vederla e vi discese; qui, tra le altre cose mirabili di cui si favoleggia, vide un cavallo di bronzo, cavo, con delle
aperture. Egli vi si affacciò e scorse là dentro un cadavere, che appariva più grande delle normali dimensioni di un uomo; e senza avergli tolto nulla tranne un anello d'oro che portava a una mano, uscì fuori. Quando ci fu la consueta riunione dei
pastori per dare al re il rendiconto mensile sullo stato delle greggi, si presentò anch'egli, con l'anello al dito; quindi,
mentre era seduto in mezzo agli altri, girò per caso il castone dell'anello verso di sé, all'interno della mano, e così divenne
invisibile ai compagni che gli sedevano accanto e che si misero a parlare di lui come se fosse andato via. Egli ne rimase
stupito e toccando di nuovo l'anello girò il castone verso l'esterno, e appena l'ebbe girato ridiventò visibile.
Riflettendo sulla cosa, volle verificare se l'anello aveva questo potere, e in effetti gli accadeva di diventare invisibile quando girava il castone verso l'interno, visibile quando lo girava verso l'esterno. Non appena si accorse di questo fece in modo di essere incluso tra i messi personali del re; una volta raggiunto l'obiettivo divenne l'amante della sua sposa, congiurò assieme a lei contro il re, lo uccise e in questo modo si impadronì del potere. Se dunque esistessero due anelli di tal genere e uno se lo mettesse al dito l'uomo giusto, l'altro l'uomo ingiusto, non ci sarebbe nessuno, a quel che sembra, così adamantino da persistere nella giustizia e avere il coraggio di astenersi dai beni altrui senza neanche toccarli, potendo prendere impunemente dal mercato ciò che vuole, entrare nelle case e congiungersi con chi vuole, uccidere e liberare di prigione chi vuole, e fare tutte le altre cose che lo renderebbero tra gli uomini pari agli dèi. Agendo così non farebbe niente di diverso dall'altro uomo, ma batterebbero entrambi la stessa via. E questa può essere definita una prova decisiva del fatto che nessuno è giusto di sua volontà, ma per costrizione, come se non ritenesse la giustizia un bene di per sé: ciascuno, là dove pensa di poter commettere ingiustizia, la commette. Ogni uomo infatti crede che sul piano personale l'ingiustizia sia molto più vantaggiosa della giustizia, e ha ragione a crederlo, come dirà chiunque voglia difendere questa tesi; poiché se uno, venuto in possesso di un simile potere, non volesse commettere ingiustizia alcuna e non toccasse i beni altrui, agli occhi di quanti lo venissero a sapere parrebbe l'uomo più infelice e più stupido, ma in faccia agli altri lo loderebbero, ingannandosi a vicenda per timore di subire ingiustizia.
Così stanno le cose.
Potremo valutare correttamente la vita delle persone di cui stiamo parlando se distingueremo l'uomo più giusto e
l'uomo più ingiusto; altrimenti no. E il criterio distintivo sarà il seguente: non togliamo nulla all'ingiustizia dell'ingiusto e
alla giustizia del giusto, ma poniamoli entrambi al più alto grado di perfezione nella loro condotta. Innanzitutto
supponiamo che l'ingiusto si comporti come i bravi artigiani: ad esempio, come un timoniere molto esperto o un medico
sa discernere nell'esercizio della propria arte ciò che è possibile da ciò che non lo è, mette mano a certe cose e ne tralascia
altre, e inoltre, se per caso commette uno sbaglio, è in grado di porvi rimedio, così anche l'uomo ingiusto deve
intraprendere le sue azioni delittuose con accortezza, senza farsi scoprire, se vuole essere veramente ingiusto. Chi viene
colto sul fatto dev'essere giudicato una persona dappoco, poiché il massimo dell'ingiustizia consiste nel sembrare giusto
senza esserlo. Pertanto a chi è perfettamente ingiusto bisogna concedere la più perfetta ingiustizia senza togliergli nulla,
anzi gli si deve permettere di procurarsi la più grande reputazione di giustizia compiendo le azioni più ingiuste; inoltre
deve avere la possibilità di rimediare agli errori che eventualmente commette, di parlare in modo persuasivo se qualche
sua ingiustizia viene denunciata, e di ricorrere alla forza nelle circostanze che la richiedono, grazie al suo coraggio, al suo
vigore e alla disponibilità di amici e sostanze.
Stabilita in questi termini la sua indole, supponiamo di collocargli accanto il giusto, uomo schietto e nobile,
desideroso, come dice Eschilo, di non sembrare buono, ma di esserlo. (2) Bisogna però togliergli l'apparenza di giustizia,
perché se sembrerà giusto, avrà per questa sua fama onori e ricompense, e non sarebbe chiaro se si comporta così per
amore di giustizia o per ricevere donativi e onori. Perciò bisogna spogliarlo di tutto, tranne che della giustizia, facendo in
modo che si trovi nella condizione opposta a quella dell'individuo di prima: senza commettere ingiustizia alcuna abbia la
fama della più grande ingiustizia, così verrà provato se la sua giustizia non si lascerà piegare dalla cattiva fama e dalle sue
conseguenze; resti però irremovibile fino alla morte, giusto per tutta la vita pur nell'apparenza di ingiustizia, e quando
entrambi saranno giunti al culmine, l'uno della giustizia, l'altro dell'ingiustizia, si giudicherà chi dei due sia più felice»
«Ahimè, caro Glaucone», feci io, «con quanto vigore levighi i due individui, come una statua da sottoporre al giudizio!».
«Faccio del mio meglio», rispose. «Rappresentando così i due caratteri credo che non sia più difficile spiegare quale
vita attende l'uno e l'altro. Diciamolo dunque; e se le mie parole riusciranno un po' rozze, non pensare, Socrate, che le
proferisca io, bensì coloro che lodano l'ingiustizia anziché la giustizia. Essi diranno che in queste condizioni il giusto sarà
frustato, torturato, imprigionato, gli saranno bruciati gli occhi, e alla fine, dopo aver subito ogni genere di mali, verrà
impalato e riconoscerà che non bisogna voler essere giusti, ma sembrarlo. Il verso di Eschilo sarebbe molto più corretto
applicarlo all'ingiusto. In realtà diranno che l'ingiusto, dal momento che dedica i suoi sforzi a una cosa attinente alla verità
e non vive secondo l'apparenza, non sembra ingiusto ma vuole esserlo, "nella mente frutto traendo da profondo solco,
donde germogliano gli accorti intendimenti".(3) In primo luogo, grazie alla sua fama di giusto, egli governa nella sua
città, poi prende moglie dove vuole e dà le figlie in sposa a chi vuole, stipula contratti e associazioni con chi gli pare, e
oltre a tutto ciò ha il vantaggio di ricavarne un guadagno, perché non gli ripugna commettere ingiustizia. Perciò, quando
prende parte a contese pubbliche e private, ne esce vincitore e ha la meglio sugli avversari; in questo modo si arricchisce,
benefica gli amici e danneggia i nemici, offre agli dèi sacrifici e doni votivi con il dovuto decoro, e si procura il favore
degli dèi e di qualsiasi uomo desideri molto meglio dell'uomo giusto. Di conseguenza è probabile che a lui, più che
all'uomo giusto, tocchi di essere caro agli dèi. Per questo motivo, Socrate, essi sostengono che gli dèi e gli uomini
riservano all'ingiusto una vita migliore che al giusto».
Io avevo già in mente una risposta da dare alle parole di Glaucone, ma suo fratello Adimanto intervenne: «Non credi,
Socrate, che ci siamo dilungati abbastanza sull'argomento?» «Ma perché?», chiesi.
«Non è stato toccata proprio la questione di cui si doveva parlare!», obiettò.
«Allora», dissi, «secondo il proverbio, il fratello assista il fratello; così anche tu, se Glaucone mostra qualche debolezza, vieni in suo aiuto. Eppure le sue parole bastano ad abbattermi e a rendermi incapace di soccorrere la giustizia».
«Sciocchezze!», replicò. «Ma ascolta quest'altro discorso, poiché dobbiamo esporre anche le argomentazioni contrarie
alle sue, quelle che lodano la giustizia e biasimano l'ingiustizia, di modo che sia più chiaro ciò che a mio avviso vuol dire
Glaucone. I padri e tutti coloro che si prendono cura di qualcuno sostengono con tono di ammonimento che bisogna
essere giusti, ma non lodano la giustizia in sé, bensì la buona fama che ne deriva, per ottenere, grazie all'apparenza di
persone giuste, cariche pubbliche, matrimoni illustri e tutti gli altri vantaggi che Glaucone ha elencato poco fa e che
spettano al giusto in virtù della sua buona reputazione. Costoro però ampliano ulteriormente gli effetti della buona fama,
perché chiamano in causa il credito di cui gode il giusto presso gli dèi e possono citare innumerevoli beni, che stando a
loro gli dèi concedono agli uomini pii. Allo stesso modo si esprimono il nobile Esiodo e Omero: l'uno asserisce che per i
giusti gli dèi fanno sì che "le querce portino sulla cima le ghiande e le api nel cavo del tronco, e le pecore lanose siano
cariche di fitto vello", (4) e molti altri beni legati a questi. Cose più o meno simili canta anche l'altro, ad esempio: "come
di un sovrano perfetto, che teme gli dèi e tiene alta giustizia; a lui la nera terra produce grano e orzo, e gli alberi son colmi
di frutti, figliano le greggi senza sosta, fornisce pesci il mare". (5) Museo e suo figlio (6) attribuiscono ai giusti doni divini
ancora più copiosi di questi: nei loro versi li conducono nell'Ade e li mettono a sdraiare, poi apparecchiano il banchetto
degli uomini pii e li fanno stare tutto il tempo cinti di corone ed ebbri, ritenendo che un'eterna ebbrezza sia la più bella
mercede della virtù. Altri poi assegnano ricompense divine ancora più grandi, dicendo che l'uomo pio e rispettoso dei
giuramenti lascia dopo di sé i figli dei figli e un'intera stirpe.
Questi per l'appunto, e altri consimili, sono gli elogi che tributano alla giustizia; invece gli empi e gli ingiusti li
seppelliscono nel fango dell'Ade e li costringono a portar acqua con un setaccio,(7) ricoprendoli d'infamia quando sono
ancora in vita, e riferiscono agli ingiusti proprio quei castighi che secondo Glaucone si attribuiscono ai giusti che passano
per ingiusti, senza saperne aggiungere di nuovi.
Questo dunque è l'elogio e il biasimo degli uni e degli altri.
Inoltre Socrate, tieni conto di un altro genere di argomentazioni sulla giustizia e l'ingiustizia. che viene espresso sia in
prosa sia dai poeti. Tutti conclamano a una voce che la temperanza e la giustizia sono cose belle, ma difficili e penose,
mentre l'intemperanza e l'ingiustizia sono piacevoli e facili da acquisire, e turpi solo per la fama e la legge; sostengono
che di solito le azioni ingiuste giovano più di quelle giuste e sono facilmente portati a considerare felici e ad onorare in
pubblico e in privato i malvagi che sono ricchi o comunque potenti, e a guardare dall'alto in basso e con disprezzo i deboli
e i poveri, pur ammettendo che sono migliori degli altri. Tra tutti questi discorsi i più sorprendenti sono quelli che
riguardano gli dèi e la virtù: essi affermano che gli dèi hanno assegnato a molti uomini buoni una vita funesta e piena di
sventure, e agli uomini d'indole contraria una sorte contraria.
Girovaghi e indovini battono alle porte dei ricchi per convincerli che grazie a sacrifici e incantesimi hanno ottenuto
dagli dèi la facoltà di riparare con divertimenti e feste a qualche colpa commessa dal padrone di casa o dai suoi antenati; e
se questi vorrà fare del male a un nemico, gli assicurano che con poca spesa potrà danneggiare ugualmente il giusto e
l'ingiusto mediante certi incantesimi e nodi magici, poiché, a quanto dicono, essi persuadono gli dèi a mettersi al loro
servizio. A tutti questi discorsi adducono le testimonianze di poeti, alcuni dei quali concedono alla malvagità una facile
realizzazione: "anche in folla è agevole attingere al male: piana è la strada, e abita molto vicino; ma davanti a virtù posero
gli dèi il sudore" (8) e una via lunga, aspra e scoscesa.
Altri chiamano Omero a testimone della possibilita che gli uomini traggano a sé gli dèi, poiché anch'egli ha detto: "si
piegano anche gli dèi, con sacrifici e con blande preghiere, con libagioni e grasso di vittime gli umani pregando li
placano, se alcun trasgredisca o un fallo commetta".(9) Inoltre presentano una folla di libri di Museo e di Orfeo,
discendenti, a loro dire, della Luna e delle Muse; (10) e sulla base di questi libri compiono i loro riti, convincendo non
solo i singoli, ma anche le città, che esistono sia per chi è ancora in vita sia per chi è morto assoluzioni e purificazioni
dalle colpe per mezzo di sacrifici e piacevoli divertimenti, ai quali danno il nome di iniziazioni capaci di liberarci dai mali
di laggiù, mentre pene terribili attendono chi non compie tali sacrifici.
Tutti questi discorsi», continuò, «caro Socrate, e tanti altri che si fanno sulla virtù e la malvagità e sulla
considerazione in cui gli uomini e gli dèi le tengono, quale effetto pensiamo che abbiano, a udirli, sull'anima di quei
giovani dotati d'ingegno e capaci, quasi gettandosi a volo su tutto ciò che si dice, di dedurne come si deve essere e quale
strada si deve percorrere per passare la vita nel modo migliore? è verosimile che un giovane ripeta a se stesso il verso di
Pindaro: "scalerò l'alto muro con la giustizia o con torti inganni" (11) e costruitomi un riparo trascorrerò in questo modo
la vita? Infatti, stando a quanto si dice, se sono giusto senza averne l'apparenza non mi viene alcun vantaggio, bensì
travagli e castighi manifesti, mentre all'ingiusto che si è acquistato fama di giustizia attribuita un'esistenza divina. Quindi,
dato che "l'apparire forza anche la verità" (12) ed è arbitro della felicità, come mi dimostrano i sapienti, debbo
assolutamente volgermi ad esso e tracciare attorno a me un'immagine adombrata di virtù, a mo' di facciata esterna,
trascinandomi dietro la volpe astuta e versatile del sapientissimo Archiloco. (13) "Ma non è facile" obietterà qualcuno
"celare sempre la propria malvagità". Nessun'altra grande impresa è agevole, risponderemo. Ad ogni modo, se vogliamo
essere felici, bisogna percorrere questa via, seguendo le orme dei nostri discorsi. Per non essere scoperti stringeremo
congiure e società, e ci sono maestri di persuasione che forniscono un'abilità concionatrice e causidica, grazie alla quale
ora persuaderemo, ora costringeremo con la forza, così da prevalere senza pagarne il fio.
"Ma non è possibile né sfuggire agli dèi né piegarli con la forza".
Ma se non esistono o non si danno pensiero delle vicende umane, perché dobbiamo preoccuparci di sfuggire loro? Se
invece esistono e si prendono cura di noi, non li conosciamo altrimenti che per sentito dire o dalle leggende (14) e dai poeti autori di genealogie; e sono proprio costoro ad affermare che gli dèi si possono convincere a passare dalla nostra
parte con sacrifici, "blande preghiere" e offerte votive. Ora, a questi poeti bisogna credere in entrambi i punti, o in
nessuno dei due. Se bisogna prestar loro fede, si deve operare ingiustamente e offrire sacrifici in espiazione delle colpe
commesse.
Infatti, se saremo giusti, eviteremo unicamente i castighi degli dèi, ma perderemo i guadagni che derivano
dall'ingiustizia; se invece saremo ingiusti godremo di questi vantaggi e per quanto trasgressori e peccatori persuaderemo
gli dèi con le nostre suppliche e ne verremo fuori impuniti. "Ma nell'Ade pagheremo il fio delle colpe commesse sulla
terra, noi stessi o i figli dei nostri figli". Ma caro, dirà il nostro amico facendo i suoi conti, le iniziazioni e gli dèi liberatori
(15) sono molto potenti, come dicono le città più forti e i figli degli dèi, ovvero i poeti e gli interpreti di stirpe divina, i
quali rivelano che le cose stanno così .
Per quale ragione dunque dovremmo ancora preferire la giustizia alla più grande ingiustizia, se acquistandocela con un
falso decoro staremo a nostro agio con gli dèi e con gli uomini sia da vivi sia da morti, come vuole l'opinione della gente
e degli individui eccellenti? In base a tutto ciò che si è detto, Socrate, con quale espediente si può fare in modo che chi
possiede una forza spirituale, o economica, o fisica, o familiare, voglia onorare la giustizia anziché ridere quando ne sente
l'elogio? D'altronde, se uno è in grado di provare la falsità di ciò che abbiamo detto e ha riconosciuto la giustizia come
sommo bene, è una persona molto indulgente e non si adira con gli ingiusti, ma sa che, ad eccezione di chi ripugna
l'ingiustizia perché è di natura divina o se ne astiene perché ha acquisito il sapere, nessun altro è giusto di sua volontà, ma
biasima l'ingiustizia per viltà, vecchiaia o qualche altra debolezza, in quanto non può commetterla. Che sia così , e
evidente, poiché il primo di loro che sale al potere è il primo a commettere ingiustizia, per quanto ne è capace. E la sola
causa di tutto ciò, Socrate, è quella da cui tutto questo discorso suo e mio ha preso le mosse per dirti: "Mirabile uomo, di
tutti voi che asserite di elogiare la giustizia, a cominciare dagli eroi delle origini, di cui sono rimasti i discorsi, fino ai
contemporanei, nessuno ha mai biasimato l'ingiustizia o lodato la giustizia se non per la fama, gli onori e i doni che ne
derivano; ma riguardo al modo in cui ciascuno dei due princì pi, in virtù della propria forza, opera nell'anima di chi lo
possiede di nascosto dagli dèi e dagli uomini, nessuno ha mai spiegato in maniera soddisfacente, né in poesia né in prosa,
che uno è il peggiore dei mali che l'anima racchiude in sé, la giustizia invece è il bene più grande. Se infatti tutti voi
diceste così sin dall'inizio e ci convinceste sin da giovani, non staremmo a sorvegliarci gli uni con gli altri per non
commettere ingiustizia, ma ciascuno sarebbe il migliore custode di se stesso, per timore di convivere col male peggiore
commettendo ingiustizia".
Questo, Socrate, e forse ancora di più potrebbero dire Trasimaco e altri sulla giustizia e l'ingiustizia, confondendo però
grossolanamente le loro caratteristiche, a mio parere. Ma io, non ho alcun bisogno di nascondertelo, profondo il massimo
sforzo nella mia esposizione perché desidero ascoltare da te la tesi opposta.
Non limitarti dunque a dimostrare nel tuo ragionamento che la giustizia è superiore all'ingiustizia, ma spiega quali
effetti, prodotti da entrambe su chi le possiede, rendono l'una di per sé un male, l'altra un bene; e lascia perdere le
opinioni, come ha raccomandato Glaucone. Se infatti in entrambi i casi non eliminerai le opinioni vere e aggiungerai
quelle false, diremo che tu non elogi la giustizia, ma la sua apparenza, e non biasimi l'essere ingiusti, ma il sembrarlo; e in
definitiva consigli di essere ingiusti di nascosto, in pieno accordo con Trasimaco sul fatto che la giustizia è un bene altrui,
ovvero l'interesse del più forte, mentre l'ingiustizia è utile e vantaggiosa a se stessa e dannosa al più debole. Poiché
dunque hai ammesso che la giustizia fa parte dei beni più grandi, quelli che meritano di essere acquistati per ciò che ne
consegue, ma ancor più per se stessi, come la vista, l'udito, l'intelligenza, la salute e tutti gli altri beni che hanno un valore
genuino per la loro natura e non per la loro apparenza, loda la giustizia per il vantaggio che arreca di per sé a chi la
possiede, mentre l'ingiustizia arreca danno, e lascia ad altri la lode delle ricompense e della fama.
Certo io potrei accettare da altri un elogio della giustizia e un biasimo dell'ingiustizia fatto solo di lodi e di critiche alla reputazione e alle ricompense che l'una e l'altra procurano, ma non da te, a meno che non lo imponga tu stesso, dal momento che hai passato tutta la vita a esaminare nient'altro che questo problema. Non limitarti dunque a dimostrare nel tuo ragionamento che la giustizia è superiore all'ingiustizia, ma spiega quali effetti, che entrambe producono di per sé su chi le possiede, rendono l'una un bene, l'altra un male, a prescindere dal fatto che restino o meno celati agli dèi e agli uomini».
Io avevo sempre ammirato il carattere di Glaucone e di Adimanto, ma allora, all'udire quelle parole, provai una gioia
particolare e dissi: «Figli di quel grand'uomo, (16) l'amante di Glaucone non ha fatto male a esordire, nell'elegia che vi ha
dedicato per esservi distinti nella battaglia di Megara, (17) con queste parole: «figli di Aristone, divina progenie d'uomo
illustre». Questo, amici, mi sembra ben detto: c'è infatti qualcosa di veramente divino in voi, se non credete che
l'ingiustizia sia migliore della giustizia, pur essendo capaci di parlare così in suo favore. E mi sembra che veramente non
ne siate convinti; lo arguisco più che altro dal vostro comportamento, poiché in base alle parole in sé non vi crederei. Ma
quanto più ho fiducia in voi, tanto più sono incerto sul da farsi. Non so come aiutarvi, e mi sembra di non averne le
capacità; me lo conferma il fatto che non avete accettato gli argomenti con cui, rispondendo a Trasimaco, mi illudevo di
dimostrare che la giustizia è migliore dell'ingiustizia. Ma d'altra parte non posso non aiutarvi, perché temo sia un'empietà
rinunciare ad assistere la giustizia messa sotto accusa e non prestarle aiuto, finché ho fiato e posso parlare.
Perciò la soluzione migliore è soccorrerla come posso».
Allora Glaucone e gli altri mi pregarono di aiutarli in ogni modo e di non lasciar cadere il discorso, ma di indagare la
natura della giustizia e dell'ingiustizia e l'utile che l'una e l'altra veramente arreca. Allora io espressi la mia opinione: «A
mio parere la ricerca che stiamo per intraprendere non è di poco conto, ma si addice a chi abbia una vista acuta. Perciò,
dal momento che noi non siamo all'altezza, mi sembra che questa ricerca si debba condurre come se si ordinasse a persone dalla vista non molto acuta di leggere da lontano lettere scritte in piccolo, e poi a qualcuno venisse in mente che
le stesse lettere si trovano da qualche altra parte, scritte più grosse e su una tavola più grande; sarebbe allora una vera
fortuna, penso, leggere prima queste ultime e poi esaminare quelle più piccole, per vedere se sono le stesse».
«Benissimo!», disse Adimanto. «Ma quale affinità, Socrate, vedi tra questo procedimento e la ricerca del giusto?» «Te
lo dirò», risposi. «Noi diciamo che esiste la giustizia di un singolo individuo, ma anche la giustizia di un'intera città?»
«Certamente».
«E la città non è più grande di un singolo individuo?» «Sì , è più grande», rispose.
«Forse allora sulla tavola più grande ci sarà una giustizia più forte e più facile da comprendere. Perciò, se volete,
ricerchiamo prima di tutto la sua natura nelle città; poi esaminiamola anche nel singolo individuo, cercando di cogliere
nell'aspetto più piccolo la conformità con quello più grande».
«Mi sembra che tu dica bene», fece lui.
«Quindi», continuai, «se assistessimo teoricamente alla nascita di una città, vedremmo anche nascere la giustizia e
l'ingiustizia?» «Forse si», rispose.
«E se ciò si verifica, non c'è la speranza di scorgere più facilmente ciò che cerchiamo?» «Senz'altro».
«Vi sembra allora che si debba tentare di condurre a fondo l'impresa? Rifletteteci, perché credo non sia un'opera da
poco».
«Abbiamo riflettuto», rispose Adimanto. «Fa' come hai detto».
«A mio parere», incominciai, «una città nasce perché ciascuno di noi non è autosufficiente, ma ha bisogno di molte
cose; o a quale altro principio credi che sia dovuta la fondazione di una città?» «A nessun altro», rispose.
«Così gli uomini si associano tra loro per le varie necessità di cui hanno bisogno; e quando hanno raccolto in un'unica
sede molte persone per ricevere aiuto dalla comunanza reciproca, nasce quella coabitazione cui diamo il nome di città.
Non è così ?» «Certamente».
«Quando dunque l'uno dà qualcosa all'altro, se gliela dà, o da lui la riceve, non pensa che sia per sé più vantaggioso?»
«Sicuro».
«Allora», proseguii, «costruiamo teoricamente una città, sin dalle fondamenta. La creerà, a quanto pare, il nostro
bisogno».
«Come no?» «Ma il bisogno primario e più grande è procurarsi il nutrimento per continuare a vivere».
«Assolutamente».
«Il secondo è quello di un'abitazione, il terzo quello di un vestito e di necessità simili».
«è così ».
«E allora», dissi, «come farà fronte la città alla richiesta di tanti mezzi? Un individuo dovrà fare il contadino, un altro
l'architetto, un altro ancora il tessitore? Dovremo anche aggiungere un calzolaio o qualcun altro che cura le esigenze del
corpo?» «Certamente».
«Allora il nucleo essenziale della città sarebbe composto da quattro o cinque uomini».
«Così pare».
«Quindi ciascuno di loro deve mettere la propria attività a disposizione di tutti, ad esempio il contadino, che è uno
solo, deve sostentare quattro persone e spendere un tempo e una fatica quadrupla per procurare il cibo e metterlo in
comune con gli altri? Oppure, senza darsi pensiero di loro, deve produrre per sé solo la quarta parte di questo cibo in un
quarto di tempo, impegnando gli altri tre quarti nel provvedersi rispettivamente della casa, del vestito e delle scarpe, e non
prendersi la briga di farne parte agli altri, ma occuparsi da sé dei propri affari?» Adimanto rispose: «Ma forse, Socrate, il
primo sistema è più facile del secondo».
«Nulla di strano, per Zeus!», replicai. «Le tue parole mi fanno riflettere che innanzitutto ciascuno di noi non nasce
identico agli altri, ma con una precisa disposizione per una particolare attività. Non ti pare?» «Sì ».
«Allora è meglio quando un solo individuo pratica molti mestieri o quando ne pratica uno solo?» «Quando ne pratica
uno solo», rispose.
«Ma è anche chiaro, credo, che se uno lascia passare il momento opportuno per fare una cosa, questa va in malora».
«è chiaro, certo».
«Perché l'oggetto del lavoro, credo, non è disposto ad aspettare il comodo del lavoratore, ma è necessario che il
lavoratore segua il proprio lavoro non come un'occupazione accessoria».
«Sì , è necessario».
«In base a questo, ogni cosa riesce meglio, più spesso e più facilmente quando si pratica una sola attività secondo le
proprie inclinazioni e a tempo debito, liberi da altre occupazioni».
«Senz'altro».
«Allora, Adimanto, per le esigenze di cui parlavamo occorrono più di quattro cittadini. Il contadino, a quanto pare,
non costruirà da sé l'aratro, se dev'essere un buon aratro, né la zappa, né gli altri attrezzi agricoli. Lo stesso vale per
l'architetto: anch'egli ha bisogno di molti utensili. E così anche il tessitore e il calzolaio. O no?» «è vero».
«Ecco che falegnami, fabbri e molti artigiani come loro si associano alla nostra piccola città e la ingrossano».
«Certo».
«Ma non sarebbe ancora molto grande se aggiungessimo a loro bovari, pecorai e altri pastori, per fornire ai contadini
buoi per arare, ai costruttori di case e ai contadini animali da soma per il trasporto di materiale, ai tessitori e ai calzolai
pelli e lana».
«Ma una città che avesse tutto questo non sarebbe nemmeno piccola», disse.
«D'altra parte, però», continuai, «fondare questa città in un luogo tale da non richiedere l'importazione di merci, è
pressoché impossibile».
«Sì , è impossibile».
«Quindi avrà ancora bisogno di altre persone, che importeranno da un'altra città ciò che le occorre».
«Ne avrà bisogno».
«E se chi ha questo incarico partirà a mani vuote, senza portare con sé nulla di quanto occorre a chi fornisce le merci
d'importazione di cui necessitano i nostri cittadini, tornerà a mani vuote. O no?» «Mi sembra di sì ».
«Pertanto la produzione interna deve non solo bastare al fabbisogno dei cittadini, ma anche soddisfare in qualità e
quantità le esigenze di coloro da cui importano».
«Deve, certo».
«Allora la nostra città ha bisogno di un maggior numero di contadini e degli altri artigiani».
«Sì , di un maggior numero».
«Occorrono inoltre quegli altri addetti all'importazione ed esportazione di ciascun prodotto, cioè i mercanti. O no?»
«Sì ».
«Dunque avremo bisogno anche di mercanti».
«Certamente».
«E se il commercio si effettua per mare, avrà anche bisogno di parecchie altre persone esperte nella navigazione».
«Certo, di parecchie persone».
«E come si scambieranno i prodotti del proprio lavoro all'interno della città stessa? Questo è lo scopo per cui ci siamo
riuniti e abbiamo fondato una città».
«è chiaro», rispose: «vendendo e comprando».
«Di conseguenza avremo un mercato e una moneta comunemente accettata per la compravendita».
«Certamente».
«E se il contadino o un altro artigiano, quando porta al mercato qualche suo prodotto, non arriva nello stesso momento
di chi ha bisogno di comprare da lui, non attenderà al proprio lavoro per starsene seduto al mercato?» «Nient'affatto»,
rispose. «Ci sono degli addetti che si incaricano di ovviare a questo inconveniente; nelle città ben amministrate sono per
lo più le persone fisicamente più deboli e inadatte a svolgere un'altra attività. Essi devono rimanere intorno alla piazza del
mercato, acquistare per denaro le merci da chi ha bisogno di vendere e poi passarle, sempre per denaro, a chi ha bisogno
di comprare».
«Allora», dissi, «questo bisogno fa nascere nella nostra città i bottegai. Non chiamiamo forse bottegai quelli che
esercitano le operazioni di compravendita stando fissi al mercato, e mercanti quelli che vanno in giro per le città?»
«Sicuro».
«Ma ci sono ancora, mi sembra, altri inservienti, i quali non meritano molto di essere accolti in una comunità per le
loro doti intellettive, ma possiedono una forza fisica atta a sopportare le fatiche: costoro sono detti, credo, salariati perché
vendono l'uso della loro forza e chiamano questo valore salario. Non è così ?» «Certo».
«A quanto pare, anche i salariati completano la città».
«Mi pare di sì ».
«Quindi, Adimanto, la nostra città è ormai cresciuta a tal punto da essere perfetta?» «Forse».
«E allora dove saranno la giustizia e l'ingiustizia? Assieme a quale degli elementi che abbiamo preso in esame sono
nate?» «Io non lo so, Socrate», rispose, «a meno che non si trovino in qualche bisogno reciproco di queste persone».
«Forse hai ragione», ripresi, «e non bisogna esitare a esaminare il problema. Innanzitutto quindi vediamo in che modo
vivranno i cittadini così organizzati. Quale altro impegno avranno se non produrre cibo, vino, indumenti e calzature? Poi
si costruiranno le case e d'estate lavoreranno seminudi e scalzi, d'inverno ben coperti e calzati. Si nutriranno ricavando
farina dall'orzo e dal frumento, cuocendo e impastando, e serviranno ottime focacce e pani su un canna o su foglie pulite;
e sdraiati su giacigli cosparsi di smilace (18) e mirto banchetteranno essi e i loro figli bevendo vino e cantando inni agli
dèi col capo cinto di corone. Vivranno insieme piacevolmente e non metteranno al mondo più figli di quanto consentano
le loro sostanze, per timore della povertà e della guerra».
A quel punto prese la parola Glaucone: «A quanto sembra, tu fai pranzare questi uomini senza companatico!».
«è vero», dissi. «Mi sono dimenticato che avranno anche il companatico, cioè sale, olive, formaggio, e cuoceranno
bulbi e verdure, come si suole fare in campagna. Imbandiremo loro anche pasticci di fichi, ceci e fave, e arrostiranno al
fuoco, sotto la cenere, bacche di mirto e ghiande, bevendo moderatamente; così passeranno la vita in pace e in buona
salute, com'è naturale, moriranno vecchi e trasmetteranno un analogo modo di vivere ai loro discendenti».
Ed egli replicò: «Socrate, se fondassi una città di porci, li pasceresti con un cibo diverso da questo?» «Ma allora come
bisogna fare, Glaucone?», domandai.
«Come si fa di solito», rispose. «Chi non vuole stare scomodo deve sdraiarsi su un lettino, credo, e prendere il cibo da
una tavola, mangiando condimenti e dolci come gli uomini d'oggi».
«Bene», dissi, «ora capisco. A quanto pare non stiamo ricercando l'origine di una semplice città, bensì di una città che
vive nel lusso. E forse non è un male, poiché esaminandone anche una di questo genere forse potremo vedere come negli Stati nascono la giustizia e l'ingiustizia. Comunque la vera città mi pare quella che abbiamo descritto, una città sana; ma se
volete, consideriamo anche una città affetta da infiammazione: nulla lo vieta. A quanto pare, alcuni non si
accontenteranno di queste prescrizioni e di questo tenore di vita, ma aggiungeranno lettini, tavole e le altre suppellettili, e
poi condimenti, profumi, incensi, etere, manicaretti e ogni sorta di simili raffinatezze. Inoltre non devono essere più
tenute per necessarie le cose che abbiamo elencato prima, case, indumenti e calzature, ma bisogna scomodare la pittura e
il ricamo e possedere oro, avorio e ogni altra materia preziosa. Non è così ?» «Sì », rispose.
«Perciò si deve nuovamente ingrandire la città, poiché quella sana non basta più, ma ora va riempita di una massa di
gente che non abita più nelle città per procurarsi il necessario: ad esempio i cacciatori e gli imitatori di ogni specie, molti
che si occupano del disegno e dei colori oppure della musica, i poeti e i loro attendenti, rapsodi, attori, coreuti, impresari,
costruttori di oggetti per tutti gli usi, in particolare per la cosmesi femminile. E ci occorrerà anche un numero maggiore di
servitori: non ti sembra che avremo bisogno di pedagoghi, balie, nutrici, acconciatrici, barbieri, e poi di cuochi e
macellai? Inoltre avremo bisogno anche di porcari: nella città di prima non ne avevamo, perché non erano necessari, ma
in questa occorrono anche loro. Ci vorranno anche molti altri animali da pascolo, se c'è chi ne mangia. Non è vero?»
«Come no?» «E con questo tenore di vita non ci serviranno molto più di prima anche i medici?» «Sì , molto di più».
«E il territorio, che bastava a nutrire gli abitanti di allora, diventerà piccolo, da sufficiente che era. Non è forse così ?»
«E così », rispose.
«Dobbiamo pertanto ritagliarci una fetta del paese confinante, se vogliamo avere terra sufficiente da pascolare e arare,
e quelli devono fare altrettanto col nostro territorio, se anche loro si abbandonano a un acquisto sconfinato di ricchezze,
andando oltre i limiti del necessario?» «è davvero inevitabile, Socrate», rispose.
«E poi faremo la guerra, Glaucone? O come andrà a finire?» «Andrà a finire così », disse.
«Non stiamo ora a questionare», continuai, «se la guerra arreca un male o un bene; limitiamoci a dire che abbiamo
trovato l'origine della guerra in quelle cose che quando si verificano procurano alle città i mali più gravi, pubblici e
privati».
«Senza dubbio».
«Perciò, caro amico, bisogna ingrandire la città non di poco, ma di un intero esercito, che uscirà in campo aperto e
combatterà contro gli aggressori in difesa di tutti i possedimenti e delle persone che poco fa abbiamo elencato».
«Ma come?», obiettò. «I cittadini stessi non ne saranno capaci?» «No», risposi, «almeno se tu e tutti noi abbiamo
stipulato un buon accordo, quando abbiamo dato forma alla città: abbiamo convenuto, se ti ricordi, che è impossibile per
una sola persona praticare bene molte arti».
«Hai ragione», ammise.
«E allora?», incalzai. «L'esercizio della guerra non ti sembra un'arte?» «E come!», rispose.
«Bisogna dunque avere maggiore cura dell'arte del calzolaio che dell'arte della guerra?» «Assolutamente no».
«Però abbiamo impedito al calzolaio di mettersi a fare il contadino, il tessitore o l'architetto e gli abbiamo ordinato di
fare il calzolaio, per ottenere buoni risultati dal suo lavoro; allo stesso modo abbiamo assegnato a ciascun individuo una
sola attività, quella per cui aveva una naturale disposizione e che doveva svolgere bene, praticandola per tutta la vita
senza interessarsi degli altri lavori e senza lasciarsi sfuggire le occasioni propizie. Non è forse della massima importanza
esercitare bene iì mestiere della guerra? Oppure è così facile che un contadino o un calzolaio o chi pratica una qualsiasi
altra arte sarà allo stesso tempo anche un guerriero, mentre nessuno può essere un bravo giocatore di dama o di dadi se fin
da ragazzo non si è esercitato a tempo pieno, ma solo saltuariamente? E se impugna uno scudo o un'altra arma o
strumento di guerra, diventerà il giorno stesso un buon combattente nella fanteria o in qualche altro genere di scontro
bellico, mentre nessun altro strumento avrà mai il potere di rendere qualcuno artigiano o atleta solo per il fatto di essere
preso in mano, e non risulterà utile a chi non ha acquisito piena conoscenza e sufficiente pratica di ciascun mestiere?»
«Sarebbero strumenti molto cari!», esclamò.
«Perciò», seguitai, «quanto più importante è il compito dei guardiani,(19) tanto maggiore sarà il tempo libero che
richiede dalle altre occupazioni, nonché l'arte e l'applicazione che esige».
«Credo di sì », disse.
«E richiederà anche una natura idonea a questa occupazione?» «Come no?» «Sarà dunque nostro compito, a quanto
pare, scegliere, se ne siamo capaci, gli individui che abbiano un'indole adatta alla difesa della città».
«Certo, sarà compito nostro».
«Per Zeus», esclamai, «non ci siamo scelti un compito da poco! Tuttavia non dobbiamo comportaci da vili, almeno
per quanto le nostre forse ce lo permettono».
«No di certo», disse.
«Credi dunque», domandai, «che nel fare la guardia la natura di un cucciolo di razza differisca da quella di un giovane
di nobile famiglia?» «Cosa intendi dire?» «Faccio un esempio: tutti e due devono avere sensi acuti, velocità nell'inseguire
la preda che hanno fiutato e anche forza per afferrarla e combattere».
«Sì », disse, «hanno bisogno di tutte queste qualità».
«E in più devono essere coraggiosi, per combattere bene».
«Come no?» «Ma potrà essere coraggioso un cavallo, un cane o qualsiasi altro animale che non sia animoso? O non
hai capito che l'ardore è qualcosa di indomabile e di irremovibile, la cui presenza rende ogni anima impavida e invincibile
di fronte a ogni pericolo?» «L'ho capito».
«Allora è chiaro quali caratteristiche fisiche deve avere il guardiano».
«Sì ».
«Ed è anche chiaro che la sua caratteristica spirituale deve essere l'animosità».
«è chiaro anche questo».
«Ma uomini di questa indole, Glaucone, come potranno non essere violenti tra loro e con gli altri cittadini?» «Per
Zeus, non sarà facile evitarlo!», rispose.
«Eppure devono essere miti con i concittadini e duri con i nemici; altrimenti si annienteranno da soli, senza aspettare
che lo facciano altri prima di loro».
«è vero», disse.
«Che cosa faremo allora?», domandai. «Dove troveremo un carattere mite e ardente allo stesso tempo? La natura mite
è in certo qual modo contraria a quella animosa».
«Pare di sì ».
«D'altra parte, se il nostro uomo è privo di uno di questi due elementi, non diventerà mai un buon guardiano; ma la
loro combinazione sembra impossibile, e così ne consegue che è impossibile diventare un buon guardiano».
«Può darsi», disse.
Dopo un iniziale smarrimento, io ripensai alle parole di prima e dissi: «Il nostro imbarazzo, amico mio, è giustificato,
poiché ci siamo allontanati dall'immagine che ci eravamo proposti».
«Cioè?» «Non abbiamo tenuto conto del fatto che esistono nature dotate di queste qualità opposte, anche se non lo
immaginavamo».
«E dove?» «Lo si può vedere anche in altri animali, ma soprattutto in quello che abbiamo paragonato al guardiano. Tu
sai che l'indole naturale dei cani di razza consiste nell'essere quanto mai mansueti con i familiari e le persone conosciute,
e nel tenere un comportamento opposto con gli sconosciuti».
«Sì , lo so».
«Un caso come questo è dunque possibile», dissi, «e non andiamo contro natura cercando un guardiano che abbia tali
requisiti».
«Pare di no».
«Non ti sembra che al futuro guardiano sia indispensabile un'altra dote, il possesso di un'indole filosofica oltre che
animosa?» «E perché?», disse. «Non capisco!».
«Anche questo potrai vederlo nei cani», seguitai, «ed è un fatto straordinario in un animale».
«Che cosa?» «Che quando il cane vede uno sconosciuto, si irrita anche se non ha ricevuto da lui alcun male; viceversa,
quando vede una persona conosciuta, la saluta con affetto anche se non ha mai ricevuto da lei alcun bene. Non te ne sei
mai meravigliato?» «Finora non ci avevo proprio fatto caso», rispose. «Ma è chiaro che fa così ».
«Eppure questa sua dote naturale appare sottile e veramente filosofica».
«In che senso?» «Nel senso», dissi, «che distingue una figura amica da una nemica solo per il fatto che conosce l'una e
ignora l'altra. E come può non amare l'apprendimento chi distingue il proprio e l'altrui grazie alla conoscenza e
all'ignoranza?» «Non può non amarlo», rispose.
«Ma amare l'apprendimento», continuai, «non è la stessa cosa che essere filosofo?» «Sì , è la stessa cosa».
«Possiamo allora stabilire senza timore che anche l'uomo, se vuole essere mite con i familiari e le persone conosciute,
deve possedere un'indole filosofica e amante dell'apprendimento?» «Stabiliamolo», rispose.
«Pertanto chi vorrà essere un ottimo guardiano della città sarà filosofo, animoso, veloce e forte».
«In tutto e per tutto», disse.
«Il nostro uomo avrà dunque tali qualità. In che modo però questi guardiani saranno allevati ed educati? E l'esame di
questo problema può tornarci utile per individuare l'oggetto di tutta la nostra indagine, ossia come nascono in una città la
giustizia e l'ingiustizia? Così eviteremo di omettere un argomento importante o di tirarlo troppo in lungo».
A questo punto il fratello di Glaucone disse: «Sì , io credo proprio che questa indagine sia utile al nostro scopo».
«Per Zeus», feci io, «allora, caro Adimanto, non è da lasciar cadere, neanche se viene ad essere piuttosto lunga!».
«No di certo».
«Su allora, tracciamo in un discorso teorico l'educazione di questi uomini, come se raccontassimo delle favole e
avessimo tempo a disposizione».
«Non c'è altro da fare».
«Ma quale sarà l'educazione? Non è forse difficile trovarne una migliore di quella scoperta già da tanto tempo? Essa
consiste in sostanza nella ginnastica per il corpo e nella musica per l'anima».
«Sì , è così ».
«Ma nella nostra educazione non cominceremo prima dalla musica che dalla ginnastica?» «Come no?» «Nella
musica», chiesi, «includi le opere letterarie oppure no?» «Certo».
«Ed esse sono di due specie, l'una vera, l'altra falsa?» «Sì ».
«Allora l'educazione deve svolgersi in entrambi i campi, ma prima in quello falso?» «Non capisco cosa vuoi dire»,
rispose.
«Non capisci», ripresi, «che ai bambini raccontiamo innanzitutto delle favole? Ciò nel suo complesso è una
menzogna, che però contiene anche un fondo di verità. E noi insegniamo ai bambini le favole prima che la ginnastica».
«è così ».
«Ecco perché dicevo che bisogna praticare la musica prima che la ginnastica».
«Giusto», disse.
«E non sai che in ogni opera l'inizio è di fondamentale importanza, tanto più se si tratta di una creatura giovane e
delicata? E soprattutto a quell'età che ciascun individuo viene plasmato e segnato con l'impronta che gli si vuole
imprimere».
« Proprio così ».
«E permetteremo così , a cuor leggero, che i bambini ascoltino favole di bassa lega plasmate da persone qualsiasi e
ricevano nell'anima opinioni per lo più contrarie a quelle che, a nostro giudizio, dovranno avere quando saranno divenuti
adulti?» «No, non lo permetteremo in nessun modo».
«Perciò, a quanto pare, dobbiamo innanzitutto sorvegliare i creatori di favole, scegliendo quelle composte bene e
scartando quelle composte male. Poi convinceremo le balie e le madri a raccontare ai bambini le favole che abbiamo
approvato e a plasmare le loro anime con le favole molto più di quanto plasmino i loro corpi con le mani; ma bisogna
rigettare la maggior parte delle favole che si narrano ai giorni nostri».
«Quali?», domandò.
«Nelle favole maggiori», risposi, «vedremo riflesse anche le minori.
Infatti sia le une sia le altre devono avere la stessa impronta e produrre lo stesso effetto. Non credi?» «Sì », disse. «Ma
non capisco che cosa intendi per favole maggiori».
«Quelle che ci hanno cantato Esiodo, Omero e gli altri poeti.
Sono loro che hanno composto miti falsi e li hanno narrati, e li narrano tuttora, agli uomini».
«Quali sono», chiese, «e che cosa critichi in essi?» «Ciò che bisogna criticare più d'ogni altra cosa», risposi, «tanto più
se le menzogne narrate non sono neanche belle».
«E cioè?» «Quando nel racconto si dà una cattiva rappresentazione della natura degli dèi e degli eroi, come un pittore
che dipinge immagini per nulla simili a quelle che voleva riprodurre».
«è giusto muovere una tale critica», disse. «Ma in che senso, e in riferimento a quali miti la esprimiamo?» «In primo
luogo», risposi, «la menzogna più grave riguarda argomenti della massima importanza ed è stata proferita ignobilmente
da chi ha attribuito a Urano le azioni che compì secondo Esiodo, e a Crono la vendetta che riportò su di lui. Quanto poi a
ciò che Crono fece e subì da parte dì suo figlio, (20) neanche se fosse vero riterrei opportuno raccontarlo con tanta facilità
a persone giovani e senza giudizio, anzi sarebbe preferibile passarlo sotto silenzio; e se proprio ci fosse una necessità di
parlarne, dovrebbe udirlo in gran segreto il minor numero possibile di persone, dopo aver sacrificato non un porco, (21)
ma una vittima grande e difficile da procurarsi, così da ridurre al minimo i possibili ascoltatori».
«In effetti», disse, «questi racconti sono imbarazzanti».
«E non sono da narrare nella nostra città, Adimanto», continuai. «Né bisogna dire in presenza di un giovane che non
farebbe nulla di strano se commettesse le peggiori ingiustizie, e neppure se punisse con ogni mezzo un padre ingiusto, ma
seguirebbe l'esempio degli dèi più antichi e più grandi».
«No, per Zeus», fece lui, «anche a me sembra che non sia opportuno narrare simili storie.» «Come non lo è affatto»,
incalzai, «dire che gli dèi si fanno guerra, si tendono insidie e si combattono tra loro (il che tra l'altro non è vero), almeno
se i futuri custodi della città devono ritenere che la peggiore vergogna sia l'odio reciproco dovuto a futili, motivi.
Bisogna poi evitare di proporre loro racconti e raffigurazioni di gigantomachie e di ogni altro genere di lotta
ingaggiata dagli dèi e dagli eroi con i loro congiunti e familiari; ma se vogliamo persuaderlì in qualche modo che nessun
cittadino ha mai avuto in odio un concittadino e che questa è un'empietà, occorre piuttosto che gli anziani, uomini e
donne, ne parlino subito ai bambini, e quando essi saranno cresciuti dovranno costringere anche i poeti a scrivere storie
conformi a questi princì pi. Non bisogna invece accogliere nella città le fole di Era incatenata dal figlio (22) e di Efesto
scagliato giù dal padre quando stava per venire in aiuto della madre percossa,(23) né le battaglie degli dèi inventate da
Omero,(24) che abbiano o meno un significato allegorico. Il giovane infatti non sa distinguere ciò che è allegoria da ciò
che non lo è, ma le opinioni che accoglie a questa età diventano di solito incancellabilì e immutabili; per questo forse
bisogna fare ogni sforzo affinché le prime cose ascoltate dai giovani siano miti composti nel miglior modo possibile per
incitarli alla virtù».
«Parole sensate», ammise. «Ma se qualcuno ci chiedesse quali sono questi argomenti e questi miti, che cosa
diremmo?» E io risposi: «Adimanto, per ora io e te non siamo poeti, ma fondatori di una città; e ai fondatori di una città
spetta conoscere i modelli in base ai quali i poeti devono comporre i loro miti e impedire che li trasgrediscano, ma non
devono inventare essi stessi dei miti».
«Giusto», disse. «Ma quali sarebbero i modelli da seguire quando si parla degli dèì ?» «Più o meno questi», risposi:
«bisogna sempre rappresentare la divinità qual è veramente, tanto nell'epica quanto nella lirica e nella tragedia».
«Sì , bisogna fare questo».
«Ora, se la divinità è realmente buona, non va definita in questi termini?» «Come no?» «Ma nulla di ciò che è buono è
dannoso. O no?» «Mi pare di sì ».
«Quindi ciò che non è dannoso non arreca danno?» «In nessun modo».
«E ciò che non arreca danno compie qualcosa di male?» «Neanche questo».
«E ciò che non compie alcun male può essere causa di un male?» «E come potrebbe?» «Ma ciò che è buono non è
forse utile?» «Sì ».
«Ed è causa di benessere?» «Sì ».
«Dunque ciò che è buono non è la causa di tutto, ma è responsabile solo del bene, non del male».
«Precisamente», disse.
«Quindi la divinità», proseguii, «essendo buona, non sarà la causa di tutto, come dice la gente, ma sarà responsabile di
poche vicende umane, non di molte, perché i beni che noi possediamo sono molto minori dei mali; e mentre la causa dei
beni non va ricondotta ad altri che alla divinità, per i mali si deve ricercare una causa diversa».
«Le tue parole mi sembrano molto vere», disse.
«Allora», feci io, «non è scusabile lo stupido errore commesso da Omero o da un altro poeta a proposito degli dèi,
quando affermano che "sulla soglia di Zeus due otri son posti pieni di sorti, l'uno di buone, l'altro di tristi", e a chi Zeus dà
una mescolanza di entrambi "ora un male gli tocca, ora s'imbatte in un bene", a chi invece concede una sorte non mista,
ma attinta solo dal secondo, "mala fame lo spinge sopra la terra divina"; né si deve accettare l'idea che Zeus sia per noi
"dispensiere di beni e di mali".(25) E non approveremo se qualcuno sosterrà che la violazione dei giuramenti e della
tregua fatta da Pandaro avvenne ad opera di Atena e di Zeus,(26) o attribuirà la discordia e il giudizio delle dee a Temis e
a Zeus,(27) né si deve permettere ai giovani di sentire, come dice Eschilo, che "colpa fa nascere il dio nei mortali, quando
voglia una casa distruggere a fondo".(28) Ma se uno canta le sventure di Niobe, a cui si riferiscono questi giambi, o dei
Pelopidi (29) o di Troia o altre del genere, gli si deve impedire di ascrivere queste vicende all'opera di un dio, altrimenti
bisogna trovare per esse una giustificazione come quella che stiamo cercando ora, e dire che la divinità ha compiuto
azioni giuste e buone e che quei personaggi trassero giovamento dalla punizione ricevuta; ma non si deve permettere al
poeta di asserire che chi pagò il fio fu infelice a causa della divinità. Se invece dicessero che i malvagi, in quanto infelici,
meritarono una punizione, e scontando la propria colpa furono beneficati dalla divinità, dovremmo lasciare che dicano;
viceversa dobbiamo opporci con tutte le forze all'affermazione che un dio, pur essendo buono, è causa di sventure:
nessuno, giovane o vecchio, creatore di miti in versi o in prosa, deve proferire o ascoltare parole simili in una città che
vuole essere ben governata, perché se venissero pronunciate sarebbero empie, inutili per noi e non coerenti con se stesse».
«Questa legge mi piace», disse, «e mi unisco a te nel votarla».
«Questa dunque», ripresi, «può essere una delle leggi e dei princì pi concernenti gli dèi cui dovranno attenersi i
narratori e i poeti: la divinità non è causa di tutto, ma solo del bene».
«Ed è abbastanza», disse.
«E quale sarà la seconda legge? Credi forse che il dio sia un mago, capace di apparire a bella posta in svariate forme, e
che a volte sia proprio lui a presentarsi e cambiare il proprio aspetto in molte sembianze, a volte invece ci inganni
suscitando in noi questa impressione? Oppure credi che sia semplice e meno che mai esca dal proprio aspetto?» «Così sul
momento non saprei che dire», confessò.
«Allora senti questo. Se qualcosa esce dal proprio aspetto, non deve necessariamente mutarsi da sé o per opera altrui?»
«Necessariamente».
«Ma ciò che si trova nella condizione migliore non è il meno sogetto a essere alterato e sconvolto per opera altrui? Per
esempio, corpo per effetto di cibi, bevande e fatiche, ogni pianta per effetto del calore solare, dei venti e di accidenti
simili, quanto più sono sani e forti tanto meno subiscono alterazioni?» «Come no?» «E l'anima più coraggiosa e più
saggia non sarà la meno soggetta a sconvolgimenti e alterazioni dall'esterno?» «Sì ».
«E analogamente anche tutti gli oggetti costruiti dall'uomo, attrezzi, case e vestiti, se ben costruiti e in buono stato,
vengono minimamente alterati dal tempo e dagli altri accidenti».
«è così ».
«Allora tutto ciò che si trova in buono stato o per natura o per arte o per entrambe le cose, subisce un minimo
mutamento per opera altrui».
«A quanto pare».
«Ma la divinità e ciò che la concerne godono in tutto e per tutto della condizione migliore».
«Come no?» «Di conseguenza la divinità sarà l'essere meno soggetto ad assumere molte sembianze».
«Il meno soggetto, certamente».
«Ma può mutarsi e trasformarsi da sola?» «è evidente», rispose, «se è vero che si trasforma».
«Dunque muta se stessa in ciò che è migliore e più bello, o in ciò che è peggiore e più brutto?» «è inevitabile che si
muti in peggio», rispose, «se è vero che si trasforma; non diremo certo che la divinità è in difetto di bellezza o di virtù!».
«Hai proprio ragione», dissi. «Stando così le cose, Adimanto, ti sembra che qualcuno, non importa se dio o uomo,
possa rendersi peggiore di sua volontà?» «è impossibile».
«Perciò», ripresi, «è anche impossibile che un dio voglia trasformarsi, ma a quanto pare, avendo il più alto grado di
bellezza e di virtù, ogni dio semplicemente mantiene sempre la sua forma».
«Mi sembra che sia assolutamente inevitabile», disse.
«Quindi, carissimo», continuai, «nessun poeta venga a dirci che "dèi col sembiante d'ospiti stranieri nelle più varie
forme girano le città"; (30) e nessuno racconti menzogne su Proteo e Teti, (31) né rappresenti in tragedia o in altri generi
poetici Era trasformata in sacerdotessa che mendica «per l'alme figlie del fiume Inaco argivo»,(32) né ci stiano a
propinare molte altre fandonie di questo genere. E le madri non si lascino persuadere da costoro e non spaventino i loro
figli raccontando favole inopportune di dèi che si aggirano di notte sotto le sembianze di stranieri d'ogni tipo, per evitare
che bestemmino contro gli dèi e nello stesso tempo rendano i loro figli più vili».
«Se ne guardino!», esclamò.
«Non potrebbe però essere», chiesi, «che gli dèi sono incapaci di mutarsi da sé, ma ci fanno credere che appaiono in
svariate forme, ingannandoci e prendendosi gioco di noi?» «Forse», rispose.
«Ma come!», replicai. «La divinità sarebbe pronta a mentire a parole o coi fatti, presentandoci un'apparenza fallace di sé?» «Non so», disse.
«Non sai», ripresi, «che tutti gli dèi e gli uomini odiano la vera menzogna, se è lecito usare questa espressione?»
«Cosa intendi dire?», domandò.
«Che nessuno vuole essere coscientemente ingannato nella parte più importante di sé e sulle questioni più importanti,
ma teme più di ogni altra cosa di essere colto in fallo proprio lì ».
«Non capisco neanche ora», disse.
«Perché credi», incalzai, che io stia parlando di chissà cosa, mentre sto solo dicendo che nessuno accetterebbe mai di
accogliere e conservare nell'anima l'inganno sulla natura delle cose, e di restare così nell'ignoranza possedendo e tenendo
in sé la menzogna, anzi tutti la odiano soprattutto in questa circostanza».
«E come!», esclamò.
«Come dunque dicevo poco fa, l'ignoranza insita nell'anima di chi è ingannato si può benissimo chiamare vera
menzogna, poiché quella che si manifesta nelle parole è una copia dello stato in cui versa l'anima e un'immagine che
nasce in un secondo tempo, non la menzogna pura. Non è così ?» «Senz'altro», rispose.
«Perciò la vera menzogna è detestata non solo dagli uomini, ma anche dagli dèi».
«Mi sembra di sì ».
«E quella che si manifesta nelle parole? Quando e a chi è tanto utile da non meritare odio? Non lo diventa forse, come
un farmaco, a scopo dissuasorio, quando i nemici e quelli che consideriamo amici cercano di compiere un'azione
malvagia per un attacco di follia o per stoltezza? E nelle favole mitiche di cui abbiamo appena parlato, dato che ignoriamo
come si sono veramente svolti i fatti antichi, non rendiamo utile la menzogna modellandola il più possibile sulla verità?»
«Proprio così », rispose.
«Sotto quale aspetto allora la menzogna è utile alla divinità? Non potrebbe mentire rendendo verosimili i fatti antichi
perché li ignora?» «Ma sarebbe ridicolo!», esclamò.
«Quindi in un dio non ci può essere un poeta mentitore».
«Non mi pare».
«Potrebbe mentire allora per timore dei nemici?» «Ci mancherebbe!».
«E a causa della stoltezza o della follia dei suoi familiari?» «Ma nessun uomo stolto o pazzo è amico degli dèi»,
rispose.
«Non c'è quindi motivo per cui un dio potrebbe mentire».
«Non c'è».
«Pertanto il demonico e il divino sono in tutto e per tutto esenti da menzogna».
«Senz'altro», disse.
«Insomma, la divinità è semplice e veritiera nei fatti e nelle parole, non subisce mutamenti e non inganna gli altri né
con apparizioni, né con discorsi, né con l'invio di segni durante la veglia o in sogno».
«A sentirlo dire da te», confessò, «anch'io sono dello stesso avviso».
«Allora», ribadii, «ammetti che il secondo principio da seguire, quando si parla e si scrive poesia sugli dèi, sia che essi
non sono dei maghi intenti a trasformarsi e a sedurci con parole o fatti mendaci?» «Lo ammetto».
«Perciò, pur tributando molti elogi a Omero, non lo loderemo per il sogno inviato da Zeus ad Agamennone;(33) né
approveremo Eschilo, là dove Teti dice che Apollo, cantando alle sue nozze, "celebrava la sua bella figliolanza", "le
lunghe vite da malanni immuni, e tutte disse le mie sorti agli dèi care, poscia intonò il peana, rallegrandomi. E io senza
menzogna la diva bocca di Febo credevo fosse, ricolma d'arte mantica; ma lui che sì cantò, presente al mio banchetto, lui
che questo disse, lui fu ch'uccise il mio figliolo".(34) Quando un poeta si esprimerà sugli dèi in questi termini, ci
indigneremo con lui e non gli concederemo il coro, (35) né permetteremo ai maestri di farne uso per l'educazione dei
giovani, se i nostri guardiani devono diventare pii e divini quanto più è possibile a un uomo».
«Io convengo assolutamente su questi princì pi», disse, «e darei loro forza di legge».
Note:
- 1) Il testo tràdito, è inaccettabile perché tutte le fonti sono concordi nell'attribuire l'anello a Gige, non 'a un suo antenato', e anche la storia di seguito narrata si conforma a questa versione. Burnet corregge semplicemente "Gúgou" in "Gúge", Fraccaroli aggiunge "tou Kroísou.
- 2) Parafrasi di Eschilo, Septem adversus Thebas 592 3) Eschilo, Septem adversus Thebas 593-594. I due versi, come quello precedentemente parafrasato, sono riferiti ad Anfiarao.
- 4) Ripresa, con qualche leggera variazione, di Esiodo, Opera et dies 232-233.
- 5) Omero, Odyssea, libro 19, versi 109-113. Parte di questa citazione è ironicamente ripresa più avanti.
- 6) Museo era un mitico cantore ai quale erano attribuiti poemi d'ispirazione orfica (infatti poco sotto viene associato a
- Orfeo); il figlio cui si aliude è forse Eumolpo, mitico progenitore degli Eumolpidi, una famiglia i cui membri erano per tradizione sacerdoti dei misteri eleusini.
- 7) Allusione al castigo delle Danaidi, le cinquanta figlie di Danao che uccisero i mariti, loro cugini, la prima notte di nozze, e per questo furono condannate a versare acqua in una botte bucata o, secondo la variante qui accolta, a portarla con un setaccio; l'unica a non subire tale pena fu Ipermnestra, che a differenza delle sorelle risparmiò il proprio marito.
- 8) Esiodo, Opera et dies 287-289.
- 9) Omero, Ilias, libro 9, versi 497 e 499-501.
- 10) Orfeo è il mitico cantore tracio che con la potenza del suo canto ammansiva le fiere e muoveva alberi e rocce.
- Disceso negli Inferi, ottenne di poter riportare in vita la sposa Euridice, ma trasgredì il divieto di voltarsi a guardarla durante la risalita e la sposa gli fu tolta per sempre. La sua uccisione da parte delle Baccanti attesta il suo rapporto con i misteri dionisiaci, di cui era considerato il fondatore; sotto il suo nome fu inoltre raccolto un corpus di scritti cosmogonici ed esoterici. Orfeo era figlio della Musa Calliope e alcune fonti lo indicano come padre di Museo, la cui madre era Selene, cioè la Luna.
- 11) Libera citazione da Pindaro, frammento 201 Bowra = 213 Maehler.
- 12) Simoninde, frammento 55 Diehl.
- 13) Probabile riferimento ad Archiloco, frammento 168; 188; 196 Tarditi. Al poeta di Paro si deve forse l'archetipo della volpe come incarnazione dell'astuzia.
- 14) Ci atteniamo alla lezione "lógon" dei codici ADM,in luogo di "nómon" accolto da Burnet.
- 15) Così erano chiamate alcune divinità ctonie, come Dioniso e Demetra; nel successivo riferimento alle «città più forti» è infatti adombrata Atene, centro di irradiazione dei misteri eleusini.
- 16) Allusione ironica a Trasimaco, di cui Glaucone e Adimanto sono detti figli perché continuano il suo discorso.
- 17) Presso Megara furono combattute durante la guerra del Peloponneso due battaglie, la prima del 422, la seconda nel 409; probabilmente qui si fa riferimento a quest'ultima. L'amante di Glaucone forse è Crizia, il sanguinario capo dei Trenta Tiranni.
- 18) Pianta simile all'edera.
- 19) Nell'introdurre la classe più alta della città ideale, Platone non distingue ancora tra guerrieri e governanti; tale distinzione sarà affrontata nei libri 6 e 7.
- 20) Urano teneva i figli rinchiusi nel grembo della loro madre Gea, che spinse Crono, il più giovane di loro, a evirare il padre con un falcetto; cfr. Esiodo, Theogonia 154-182. A sua volta Crono, assunto il potere, divorava i figli appena nati perché secondo una profezia sarebbe stato spodestato da uno di essi; ma Zeus fu salvato dalla madre Rea e detronizzò il padre. Questo mito viene ripreso implicitamente nel libro 10.
- 21) Vittima sacrificale nei misteri eleusini.
- 22) Efesto legò la madre Era per farsi giurare sullo Stige di essere nato da lei per partenogenesi.
- 23) La vicenda è raccontata dal medesimo Efesto in Omero, Ilias, libro 1, versi 590-594.
- 24) Cfr. Omero, ilias, libro 20, versi 1-74 e libro 21, versi 385-513. Zeus aizzò gli dèi gli uni contro gli altri, spingendoli a combattere chi a favore dei Greci, chi a favore dei Troiani.
- 25) Omero, Ilias, libro 24, versi 527-532, con qualche variante e con l'omissione dei versi 529 e 531. L'ultimo verso non è omerico.
- 26) Cfr. Omero, Ilias, libro 4, verso 70 e seguenti.
- 27) Riferimento al gludizio di Paride, che fu l'origine della guerra di Troia.
- 28) Eschilo, frammento 160 Radt.
- 29) Famiglia che ebbe origine da Pelope, figlio di Tantalo, e da cui discendevano anche gli Atridi.
- 30) Omero, Odyssea, libro 17, versi 485-486.
- 31) Proteo era una divinità marina capace di assumere di continuo le più svariate forme; cfr. Omero, Odyssea, libro 4, verso 385 e seguenti.
- La Nereide Teti cercò inutilmente, attraverso varie metamorfosi, a sfuggire alla violenza di Peleo, dalla quale nacque Achille.
- 32) Eschilo, frammento 279,17 Radt. Si allude alla persecuzione di Era nei confronti di Io, figlia dei fiume Inaco, amata da Zeus.
- 33) Cfr. Omero, Ilias, libro 2, versi 1-34. Zeus mandò ad Agamennone un sogno ingannatore preannunciandogli la vittoria; indotto dal sogno, Agamennone sferrò un attacco contro i Troiani, ma i Greci furono sconfitti.
- 34) Eschilo, frammento 350 Radt. Non si sa di quale tragedia faccia parte il frammento.
- 35) Ad Atene, in occasione delle rappresentazioni teatrali, il poeta chiedeva all'arconte eponimo l'autorizzazione a mettere in scena un nuovo dramma e a ingaggiare il coro.