LIBRO TERZO
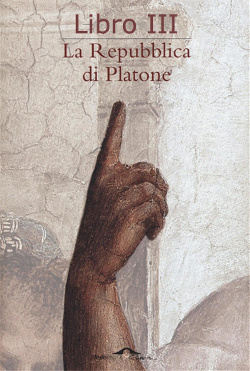 «Più o meno questi», ripresi, «a quanto sembra, sono i discorsi sugli dèi che i cittadini devono e non devono ascoltare sin dall'infanzia, se si vuole che imparino a onorare gli dèi e i genitori e a non tenere in poco conto l'amicizia reciproca».
«Più o meno questi», ripresi, «a quanto sembra, sono i discorsi sugli dèi che i cittadini devono e non devono ascoltare sin dall'infanzia, se si vuole che imparino a onorare gli dèi e i genitori e a non tenere in poco conto l'amicizia reciproca».
«E credo che la nostra opinione sia giusta», aggiunse.
«E se vogliamo che siano coraggiosi? Non bisogna fare loro, oltre a questi, discorsi che li riducano a temere la morte il meno possibile? O credi che si possa essere coraggiosi con questa paura dentro di sé?» «Io no, per Zeus!», rispose.
«E allora, se uno crede che il mondo dell'Ade esista e faccia paura, pensi che sarà impavido di fronte alla morte e in battaglia sceglierà la morte piuttosto che la sconfitta e la schiavitù?» «Nient'affatto».
«Dobbiamo perciò sorvegliare, a quanto sembra, anche coloro che si mettono a narrare questi miti, e pregarli di non diffamare con tanta disinvoltura il mondo dell'Ade, ma piuttosto di elogiarlo, perché i loro racconti di adesso non contengono nulla di vero e di utile per chi dovrà avere spirito combattivo».
«Dobbiamo fare così , certo», disse.
«Allora», proseguii, «a cominciare dai versi seguenti, cancelleremo tutte le espressioni di questo tipo: "Vorrei lavorare a salario e servire ad un altro pur senza risorse, sprovvisto di grande ricchezza, piuttosto che regnare su tutti i morti consunti";(1) e poi: "a mortali e immortali le case paressero mucide, orrende, che aborrono pure gli dèi";(2) e anche:
"ahimè, ché ancora sussiste nelle case dell'Ade un'anima e un'ombra, ma senno non ha";(3) e anche: "lui solo ha coscienza, l'altre son ombre che volano";(4) e ancora: "l'anima volò via dalle membra e scese nell'Ade, piangendo il suo fato, vigor giovanile lasciando";(5) e anche questi versi: "l'anima come fumo sotto la terra n'andò stridendo";(6) e poi: "come quando le nottole nel fondo d'un antro divino squittendo svolazzano, allorché una cada dal grappolo appeso alla roccia, ove si reggono in fila, andavano insieme stridendo".(7) Pregheremo Omero e gli altri poeti di non indignarsi se casseremo questi e tutti gli altri versi di questo tipo, non perché siano impoetici e alla gente non piaccia ascoltarli, ma perché, quanto più sono poetici, tanto meno devono udirli i fanciulli e gli uomini destinati a essere liberi e temere la schiavitù più della morte».
«Senza dubbio».
«Occorre quindi respingere anche tutti i nomi tremendi e spaventevoli che si riferiscono all'argomento: il Cocito, lo
Stige,(8) le ombre dei morti, i fantasmi e le altre cose di questo tipo che solo a nominarle fanno rabbrividire chiunque le
ascolti.(9) Forse vanno bene sotto un altro aspetto; ma noi temiamo che per un tale senso d'orrore i guardiani diventino
più impulsivi e più molli del dovuto».
«E abbiamo ragione di temerlo!», esclamò.
«Sono dunque da eliminare?» «Sì ».
«E bisogna parlare e scrivere poesia seguendo il principio opposto?» «è ovvio».
«E allora aboliremo anche i lamenti funebri e i compianti degli uomini illustri?» «è una conseguenza necessaria»,
rispose, «se anche prima si è proceduto così ».
«Considera attentamente», proseguii, «se faremo bene o no a eliminarli. Noi diciamo che l'uomo equilibrato non giudicherà un evento terribile la morte di un altro uomo equilibrato suo compagno».
«Sì , diciamo questo».
«Perciò non può compiangerlo come vittima di un evento terribile». «Certamente no».
«Ma noi affermiamo anche che soprattutto un uomo simile basta a se stesso per vivere bene e a differenza degli altri
sente il minimo bisogno del prossimo». «è vero», disse.
«Quindi meno di chiunque altro avvertirà come terribile la perdita di un figlio o di un fratello o di ricchezze o di un
altro bene analogo». «Meno di chiunque altro, certo».
«E meno di chiunque altro si lamenta, anzi sopporta con la massima tranquillità una disgrazia simile, qualora gli
capiti». «Sicuro».
«Allora faremmo bene a eliminare i lamenti funebri degli uomini insigni e a lasciarli alle donne, ma solo a quelle
dappoco, e a tutti gli uomini vili, affinché coloro che diciamo di educare alla difesa del paese aborrano di comportarsi
come queste persone». «Giusto», disse.
«E pregheremo di nuovo Omero e gli altri poeti di non rappresentare Achille, figlio di una dea, "talora disteso su un
fianco, talora invece supino, talora bocconi", "e talora, levatosi dritto, errante sulla riva del mare infecondo",(10) e
neppure "che prende con ambo le mani la cenere scura e la versa sul capo",(11) o mentre effonde tutti quegli altri pianti e
lamenti che ha descritto il poeta; e nel contempo di non raffigurare Priamo, discendente degli dèi, mentre supplica e "nel
fimo si voltola, chiamando per nome ogni guerriero".(12) Ma pregheremo ancora di più Omero di non rappresentare gli
dèi che si lamentano e dicono "oh me sventurato, me misera madre!".(13) E se proprio vogliono rappresentarli, almeno
non osino ritrarre il più grande degli dèi in maniera così difforme dal vero, da fargli dire: "ahi, che un prode a me caro attorno alla rocca inseguito veda con gli occhi, e il mio cuore ne piange";(14) e "ahimè, ahimè! Sarpedone, a me il più
caro tra gli uomini, per mano del Meneziade Patroclo è destino che cada!".(15) Se infatti, caro Adimanto, i nostri giovani
ascoltassero seriamente simili parole senza deriderle come indecorose, difficilmente uno potrebbe ritenersi indegno di
queste azioni in quanto uomo e rimproverarsi se gli capita di dire o di fare qualcosa del genere, ma intonerebbe senza
ritegno e senza forza d'animo molti lamenti e molti gemiti per dolori da poco».
«Quello che dici è verissimo», affermò.
«Ma ciò non deve accadere, come ci ha dimostrato proprio ora il nostro ragionamento; e dobbiamo attenerci ad esso,
finché qualcuno non ci persuada con un'argomentazione migliore».
«Non deve accadere, certo».
«Ma non si deve essere nemmeno facili al riso. Quando infatti ci si abbandona a una forte risata, la cosa comporta di
solito anche una forte mutazione interiore». «Mi pare di sì », disse.
«Perciò non bisogna permettere che si rappresentino uomini di valore in preda al riso, tanto meno se si tratta di
divinità». «Tanto meno, certo», fece lui.
«Quindi non accetteremo neanche questi versi di Omero sugli dèi: "inestinguibile un riso sorse tra gli dèi beati,
quando videro Efesto per la sala affannarsi".(16) Non sono da accettare, secondo il tuo ragionamento».
«Se tu vuoi qualificarlo come mio», disse: «no, non vanno ammessi di certo».
«Ma bisogna tenere in gran conto anche la verità. Se poco fa avevamo ragione, e davvero la menzogna è inutile agli
dèi, ma utile agli uomini come farmaco, è chiaro che un simile espediente deve essere lasciato ai medici, mentre i profani
non devono ricorrervi». «è chiaro», disse.
«Spetta dunque ai governanti, se mai qualcuno ne ha il diritto, mentire per ingannare i nemici o i concittadini
nell'interesse della città, mentre tutti gli altri non devono fare ricorso a un simile espediente; ma diremo che per un
cittadino privato mentire ai governanti è colpa uguale o anche maggiore di quella di un ammalato o di un atleta che non
denunci al medico o al maestro la verità sulla propria condizione fisica, o del marinaio che non riferisca al timoniere sullo
stato effettivo della nave e dell'equipaggio, ossia qual è la condotta sua e dei compagni di navigazione».
«Verissimo», disse.
«Se dunque verrà sorpreso a mentire nella città qualcun altro "di quanti sono artigiani, indovino, curatore di mali o
carpentiere",(17) costui sarà punito perché introduce una pratica sovversiva e rovinosa per la città come per una nave».
«Sì », disse, «almeno se i fatti si realizzano secondo le parole».
«E ai nostri giovani non sarà allora necessaria la temperanza?» «Come no?» «E solitamente la temperanza non
consiste soprattutto nell'obbedire ai governanti e nel comandare a propria volta ai piaceri del bere, dell'amore e del
mangiare?» «Mi sembra di sì ».
«Allora, penso, approveremo parole come quelle che Diomede pronuncia in Omero: "babbo, siedi in silenzio, e
obbedisci al mio motto";(18) e il seguito: "andavano spirando forza gli Achei, in silenzio, temendo i lor capi", (19) e tutti
gli altri versi di questo genere». «Sono ben detti».
«Ma sono forse ben dette queste parole: "pieno di vino, occhio di cane, cuore di cervo" ,(20) e quelle che seguono,
così come tutte le altre insolenze che i sudditi hanno rivolto in prosa o in poesia ai loro capi?» «Non sono ben dette».
«Non credo infatti che siano adatte alle orecchie dei giovani come invito alla temperanza; se poi offrono qualche altro
piacere, non c'è da meravigliarsene. Come la pensi tu?» «Così », rispose.
«E far dire all'uomo più saggio che per lui la cosa migliore si ha quando "siano accanto tavole piene di pane e carni, e
dal cratere vino attingendo lo porti un coppiere e nelle coppe lo mesca",(21) ti pare sia adatto alle orecchie di un giovane
per acquisire dominio di sé? O questo verso: "quanto mai triste perire di fame e seguire il destino"? (22) O Zeus che,
mentre gli altri dèi e gli uomini dormono, per il desiderio dei piaceri amorosi si dimentica facilmente di tutti i piani che ha
meditato quando lui solo vegliava, e guardando Era ne rimane colpito a tal punto che non vuole nemmeno andare in
camera da letto, ma desidera unirsi a lei lì , per terra, e dichiara di essere in preda alla passione più della prima volta in cui
si accoppiarono "di nascosto dai propri genitori";(23) o Ares e Afrodite legati da Efesto per motivi analoghi?»(24) «No,
per Zeus», rispose, «non mi sembra opportuno».
«Se però», ripresi, «uomini insigni parlano e agiscono con fermezza in ogni genere d'avversità, bisogna contemplarli e
ascoltarli, come in questi versi: "percotendosi il petto rimproverò il suo cuore: cuore, sopporta! Più crudo affanno
soffristi! "» (25) «Senz'altro», disse.
«E non bisogna poi permettere che i nostri uomini siano venali e attaccati al denaro». «Assolutamente».
«Né si deve cantare in loro presenza che "doni persuadon gli dèi, doni i re venerandi";(26) e neppure bisogna lodare
Fenice, il pedagogo di Achille, per le parole misurate con le quali lo consigliò di soccorrere gli Achei in cambio di doni,
ma in assenza di doni di non deporre l'ira. E non vorremo credere o ammettere che Achille stesso fosse tanto avido di
ricchezze da ricevere doni da Agamennone e riscattare un cadavere dietro compenso, e in caso contrario rifiutarsi».(27)
«No», disse, «non è certo giusto approvare un comportamento simile».
«Per rispetto a Omero», proseguii, «esito a dire che è un'empietà parlare così di Achille e prestare fede ad altri che lo fanno, asserendo che si rivolse ad Apollo con queste parole: "m'hai danneggiato, arciere da lungi, tra tutti gli dèi il più
funesto: te la farei certo pagare, sol che forza n'avessi!".(28) Non bisogna poi credere che abbia disobbedito al fiume, che
pure era un dio, e fosse pronto a combattere contro di lui;(29) e inoltre abbia detto della sua chioma, consacrata al fiume
Spercheo, "vorrei offrirla a Patroclo eroe",(30) che era morto, e così abbia fatto. Quanto a Ettore trascinato intorno alla
tomba di Patroclo e ai sacrifici dei prigionieri sulla pira,(31) non diremo che tutto ciò corrisponde al vero, e non
permetteremo ai nostri uomini di credere che Achille, figlio di una dea e di Peleo, uomo molto virtuoso e nipote di Zeus, e
allievo del sapientissimo Chirone,(32) fosse talmente sconvolto da avere dentro di sé due mali tra loro opposti, una
bassezza unita ad avidità e un arrogante disprezzo per gli dèi e gli uomini». «Hai ragione», disse.
«Non crediamo dunque», continuai, «e non permettiamo che si raccontino storie come queste: che Teseo figlio di
Poseidone e Piritoo figlio di Zeus si abbandonarono a rapimenti tanto delittuosi,(33) o che qualche altro figlio di un dio o
eroe avrebbe osato compiere azioni criminali ed empie come quelle che ora vengono loro attribuite calunniosamente; ma
costringiamo i poeti ad affermare che tali azioni non sono opera loro o che essi non sono figli di dèi, ma non l'una e l'altra
cosa insieme, e a non tentare di persuadere i giovani che gli dèi generano il male e gli eroi non sono affatto migliori degli
uomini. Come dicevamo prima, questi racconti non sono pii né veritieri, poiché abbiamo dimostrato che è impossibile che
dagli dèi venga il male».
«Come no?» «E in più sono dannosi per chi li ascolta: ognuno infatti sarà indulgente verso la propria malvagità,
convinto che compiono e compirono tali azioni anche "i parenti dei numi, quelli prossimi a Zeus, che sulla roccia dell'Ida
alzan nell'etere un'ara a Zeus patrio", nei quali "non è ancora svanito il sangue divino".(34) Perciò bisogna smetterla con
questi miti, perché non producano nei giovani una forte inclinazione a commettere il male». «Senza dubbio», disse.
«Bene», domandai, «quale genere di discorsi ci resta da determinare se è lecito o no? Abbiamo precisato come
bisogna parlare degli dèi, dei demoni, degli eroi e del mondo dell'Ade». «Per l'appunto», disse.
«Non resterebbe quindi quello che concerne gli uomini?» «è evidente».
«Questo però, amico, non possiamo stabilirlo, almeno per il momento».
«Perché?» «Perché diremo, penso, che i poeti e i narratori parlano degli uomini nel modo più sbagliato, affermando
che molti ingiusti sono felici e i giusti sono infelici, e che il commettere ingiustizia giova, se non viene scoperto, mentre
la giustizia è un bene per gli altri e un danno per se stessi; e noi vieteremo loro di parlare così , anzi ordineremo di cantare
e raccontare il contrario di questo.
Non credi?» «Ne sono sicuro!», rispose.
«Se dunque convieni che ho ragione, dovrò dire che tu sei d'accordo su ciò che da tempo andiamo cercando?» «Giusta
supposizione, la tua», disse.
«Converremo quindi che questi discorsi sugli uomini andranno fatti solo quando avremo scoperto cosa sia la giustizia
e come possa per sua natura giovare a chi la pratica, a prescindere dal fatto che sembri o non sembri giusto?» «è
verissimo», rispose.
«Per quanto riguarda il contenuto basta così . Subito dopo va preso in considerazione, credo, l'aspetto dello stile, e
allora avremo esaminato compiutamente ciò che si deve dire e come lo si deve dire».
Allora Adimanto obiettò: «Non capisco le tue parole».
«Eppure devi!», replicai. «Ma forse capirai meglio in questo modo. Tutti i racconti dei mitologi e dei poeti non sono
un'esposizione di vicende passate, presenti o future?» «E che altro?», disse.
«E non le svolgono forse con una narrazione in forma diretta, o con una imitativa, o con entrambe le forme?» «Anche
questo punto», rispose, «devo comprenderlo più chiaramente».
«A quanto pare», feci io, «sono un maestro ridicolo e oscuro; perciò, come chi non sa esprimersi, cercherò di spiegarti
ciò che voglio dire non nell'insieme, ma pezzo per pezzo. Dimmi un po': conosci l'inizio dell'Iliade, in cui il poeta dice
che Crise prega Agamennone di liberare sua figlia, ma quello si adira e allora il vecchio, non essendo riuscito nel suo
intento, invoca la maledizione divina sugli Achei?» «Sì , certo».
«Quindi sai che fino a questi versi: "e pregava tutti gli Achei, ma soprattutto i due Atridi, condottieri di genti",(35) è il
poeta stesso che parla e non tenta neppure di sviare la nostra mente come se fosse un altro, e non lui, a parlare; ma da qui in avanti prosegue come se lui stesso fosse Crise e cerca in ogni modo di farci credere che non stia parlando Omero, bensì il vecchio sacerdote. E pressappoco così è stata composta tutta la rimanente narrazione delle vicende di Ilio, di Itaca e di tutta l'Odissea». «Precisamente», disse.
«E non c'è narrazione ogni volta che riporta i discorsi e gli avvenimenti tra un discorso e l'altro?» «Come no?» «Ma
quando riferisce un discorso mettendosi nei panni di un altro, non diremo che adegua il più possibile il proprio modo di
esprimersi a ogni singolo personaggio che introduce a parlare?» «Lo diremo: e allora?» «E il conformarsi a un altro nella
voce o nell'aspetto non è forse imitare colui al quale ci si assimila?» «Ebbene?» «In tal caso, a quanto pare, Omero e gli
altri poeti sviluppano il racconto tramite l'imitazione».
«Senza dubbio».
«Ma se il poeta non si nascondesse mai, tutta la sua poesia e la sua narrazione sarebbero prive di imitazione. E perché
tu non mi ripeta che ancora non capisci, ti spiegherò come questo può accadere. Se Omero, dopo aver raccontato che Crise giunse con il riscatto per la figlia a supplicare gli Achei, e soprattutto i re, non si fosse messo a parlare come se
fosse divenuto Crise, ma come se fosse ancora Omero, sai che non ci sarebbe stata imitazione, ma semplice narrazione. E
si svolgerebbe più o meno così (lo dirò in prosa, dato che non sono un poeta): "Il sacerdote, al suo arrivo, pregò gli dèi di
concedere loro di prendere Troia e di salvarsi, e li supplicò di liberare sua figlia accettando il riscatto, per rispetto del dio.
A queste parole gli altri lo onorarono e acconsentirono, ma Agamennone s'infuriò e gli ingiunse di andarsene subito e di
non ritornare più, altrimenti lo scettro e le bende del dio non sarebbero valse a proteggerlo. Aggiunse che prima di
liberare sua figlia, ella sarebbe invecchiata con lui ad Argo; gli ordinò quindi di andarsene e di non irritarlo, se voleva
tornare sano e salvo a casa. All'udire queste minacce il vecchio ebbe paura e partì in silenzio, ma quando fu lontano
dall'accampamento rivolse molte preghiere ad Apollo, invocando il dio con i suoi appellativi, ricordandogli e
chiedendogli se mai gli avesse fatto un dono gradito costruendogli templi o sacrificandogli vittime; in cambio di questo lo
pregò di far pagare agli Achei con le sue frecce le lacrime da lui versate".(36) Così , amico mio», conclusi, «si fa una
narrazione semplice senza imitazione». «Ora capisco», disse.
«Cerca allora di capire», continuai, «che si ha una narrazione contraria a questa quando si eliminano le parole del
poeta intercalate tra i discorsi diretti, conservando i dialoghi».
«Capisco anche», disse, «che questa è la struttura della tragedia».
«Hai inteso perfettamente», risposi, «e penso di poterti ormai chiarire ciò che prima non ero in grado di spiegarti, cioè
che nella poesia e nella narrazione di miti c'è un genere che si basa completamente sull'imitazione, ossia, come tu dici, la
tragedia e la commedia, un altro genere in cui il poeta stesso riferisce i fatti (e questo lo puoi trovare soprattutto nei
ditirambi),(37) e infine un terzo genere che ricorre a entrambe le forme e si trova nella poesia epica e in molti altri
componimenti, se mi comprendi».
«Certo», disse, «ora capisco ciò che volevi dire prima».
«Ma ricordati anche che prima ancora abbiamo detto di aver già trattato l'aspetto del contenuto e di dover ancora
esaminare l'aspetto dello stile». «Certo, me ne ricordo».
«E io intendevo dire proprio questo, che dobbiamo decidere di comune accordo se permetteremo ai poeti di usare nelle
loro narrazioni uno stile imitativo, o uno stile solo in parte imitativo, distinguendo i casi che lo richiedono da quelli che
non lo richiedono, oppure uno stile niente affatto imitativo».
«Indovino», disse, «che tu vuoi considerare se accoglieremo o meno nella città la tragedia e la commedia».
«Forse», dissi, «ma forse anche qualcosa di più. Io non lo so ancora, ma bisogna andare là dove il discorso, come un
soffio di vento, ci porta». «Ben detto!», esclamò.
«Ora, Adimanto, rifletti se i nostri guardiani debbano essere esperti di imitazione oppure no. Dal principio fissato in
precedenza non deriva anche che ciascuno può esercitare bene un solo mestiere e non molti, anzi, se tentasse di praticare
varie attività, in nessuna di essere riuscirebbe a ottenere buona fama?» «E come può essere diversamente?» «Allora i
medesimo discorso vale anche per l'imitazione, vale a dire la stessa persona non è in grado di imitare più cose bene come
una sola?» «No di certo».
«Sarà quindi difficile che uno si dedichi ad attività importanti e nello stesso tempo imiti con perizia molte cose, dal
momento che i medesimi poeti non sanno eseguire bene neppure le due imitazioni che paiono vicine tra loro, cioè la
tragedia e la commedia. Non le hai chiamate poco fa imitazioni?» «Certo, e tu dici il vero: i medesimi poeti non lo sanno
fare».
«E neppure si può essere rapsodi e attori insieme». «Vero».
«Ma gli attori delle commedie non sono gli stessi delle tragedie; eppure sono tutte imitazioni. O no?» «Sì , sono
imitazioni».
«Inoltre, Adimanto, mi pare che la natura umana sia suddivisa in pezzetti ancor più piccoli di questi, tanto da non
essere in grado di imitare bene molte cose o di eseguire proprio ciò che viene riprodotto nelle imitazioni».
«è verissimo», disse.
«Se dunque riterremo ancora valida la nostra prima tesi, ovvero che i nostri guardiani devono trascurare tutte le altre
attività per essere scrupolosissimi artefici della libertà cittadina e non devono occuparsi di nient'altro che non miri a
questo scopo, essi non dovrebbero fare né imitare altro. Se poi eseguono delle imitazioni, devono imitare sin da ragazzi i
modelli che si addicono a loro, cioè gli uomini coraggiosi, temperanti, pii, nobili d'animo, e tutte le altre qualità di questo
tipo, ma non devono compiere né essere capaci di imitare ciò che è indegno di un uomo libero o altre azioni riprovevoli,
per evitare che ne traggano il bel guadagno di essere uguali a ciò che imitano. O non ti sei accorto che le imitazioni, se
cominciando dalla giovane età perdurano anche in seguito, si mutano in abitudini e in disposizione naturale del corpo,
della voce e della mente?» «E come!», rispose.
«Pertanto», ripresi, «non permetteremo a coloro che affermiamo di avere in cura e che devono diventare persone
oneste di imitare, essi che sono uomini, una donna, giovane o vecchia, mentre insulta il marito o inveisce contro gli dèi e
si vanta della sua presunta felicità, o al contrario mentre è immersa nelle disgrazie, nei lutti e nei lamenti, e tanto meno
quando è malata o innamorata o ha le doglie».(38) «Assolutamente» disse.
«E non devono imitare schiave e schiavi che compiono azioni servili». «Neanche questo».
«E nemmeno, a quanto pare, uomini malvagi e vili che si comportano all'opposto di come abbiamo detto poc'anzi, che
si ingiuriano, si sbeffeggiano e indulgono al turpiloquio sia da ubriachi sia da sobri, e tutte le altre azioni sconvenienti che
persone simili compiono, con le parole e coi fatti, verso sé e verso gli altri.
Credo poi che non si debbano neanche abituare i guardiani a imitare i discorsi e le azioni dei pazzi: bisogna sì
conoscere i pazzi e i malvagi, uomini e donne, ma nulla di loro va compiuto o imitato». «Verissimo», disse.
«E allora», domandai, «devono imitare i fabbri o altri artigiani, i rematori delle triremi o quelli che danno loro il
tempo, o qualche altra attività connessa a queste?» «E come potranno farlo», disse, «se non sarà loro lecito neanche
pensare a queste attività?» «Imiteranno forse cavalli che nitriscono, tori che muggiscono, fiumi che mormorano, il mare
che romba, i tuoni e così via?» «Ma è stato loro vietato», rispose, «di essere pazzi e di rassemblarsi ai pazzi».
«Se comprendo il tuo pensiero», dissi, «esiste una forma di espressione e di narrazione di cui si servirà l'uomo
realmente onesto, quando deve raccontare qualcosa, e un'altra forma, dissimile da questa, alla quale si atterrà sempre nella sua esposizione chi ha una natura e un'educazione contraria».
«E quali sono queste due forme?», domandò.
«Mi sembra», risposi, «che l'uomo equilibrato, quando nella sua narrazione arriverà a citare un detto o un fatto di un
uomo onesto, vorrà riferirlo immedesimandosi in lui e non si vergognerà di questa imitazione, soprattutto se è rivolta
all'uomo onesto che agisce in modo sicuro e assennato, un po' meno se è caduto vittima di malattie o dell'amore,
dell'ubriachezza o di qualche altra disgrazia; quando però s'imbatterà in una persona indegna, non vorrà conformarsi
seriamente a chi gli è inferiore, se non occasionalmente, quando compie qualcosa di buono, ma se ne vergognerà, perché
non è esercitato a imitare persone simili e nello stesso tempo gli dà noia modellare e atteggiare se stesso agli esempi di
uomini più vili, che in cuor suo disprezza, a meno che non sia per gioco». «è naturale», disse.
«Farà quindi uso di un'esposizione come quella che abbiamo citato poco fa a proposito dei versi di Omero, e il suo
stile sarà partecipe di entrambe le forme, dell'imitazione e della narrazione pura e semplice,(39) ma con una piccola parte
imitativa all'interno di una lunga narrazione? O uello che dico non vale nulla?» «Tutt'altro: hai esposto perfettamente
come dev'essere il modello del nostro retore».
«Chi invece non gli assomiglia», proseguii, «quanto più sarà scadente, tanto più si abbandonerà a ogni sorta di
narrazione e non riterrà nulla indegno di lui, al punto che si sforzerà di imitare seriamente, e al cospetto di molti, qualsiasi
cosa, anche ciò che dicevamo prima: tuoni e strepito di venti, di grandine, di ruote e di argani,(40) suoni di trombe, di
flauti, di zampogne e di ogni altro strumento, e ancora versi di cani, di pecore e di uccelli. E il suo stile si baserà tutto
sull'imitazione attraverso i suoni e i gesti, o avrà solo una minima parte narrativa?» «Anche questo è inevitabile», rispose.
«Ecco», ribadii, «queste sono le due forme di espressione di cui parlavo». «Sì , sono queste», ammise.
«La prima forma quindi comporta piccole variazioni, e se conferisce al proprio stile l'armonia e il ritmo che gli si
addice, chi parla correttamente può mantenere quasi sempre la stessa e unica armonia, poiché le variazioni sono piccole, e
parimenti anche un ritmo analogo?» «è senz'altro così », disse.
«E l'altra forma? Non ha forse bisogno del contrario, ossia di tutte le armonie e di tutti i ritmi, se la si vuole esprimere
in modo appropriato, dato che comporta ogni genere di mutazioni?» «Proprio così !».
«Perciò tutti i poeti e coloro che hanno qualcosa da dire si trovano di fronte o l'uno o l'altro tipo di espressione, o uno
risultante dalla mescolanza di entrambi?» «è inevitabile», rispose.
«E allora cosa faremo?», domandai. «Accoglieremo nella città tutti questi modelli, o solo uno dei due puri, o quello
misto?» «Se prevale il mio parere», rispose, «accoglieremo l'imitatore puro di ciò che è conveniente».
«Eppure, Adimanto, è piacevole anche il tipo misto, ma il tipo opposto a quello che hai scelto è di gran lunga il più
gradito a fanciulli, precettori e alla massa». «Sì , è il più gradito!».
«Ma forse», continuai, «potresti obiettare che non si accorda alla nostra costituzione perché tra noi non c'è un uomo
doppio né molteplice, dato che ciascuno esercita una sola attività». «Certo, non si accorda».
«Per questo motivo allora solo in questa città troveremo che il calzolaio è calzolaio e non pratica, oltre alla sua arte,
anche quella del timoniere, il contadino è contadino e non esercita, oltre all'agricoltura, anche il mestiere di giudice, e il
guerriero è guerriero e non si occupa di affari oltre che della guerra, e così via?» «è vero», disse.
«Perciò, a quanto pare, se un uomo capace di assumere con abilità ogni aspetto e di imitare qualsiasi cosa giungesse
nella nostra città coll'intento di declamare i suoi componimenti, lo riveriremmo come un essere sacro, mirabile e
piacevole, ma gli diremmo che nella nostra città un individuo simile non esiste né è lecito che esista, e lo spediremmo in
un'altra città dopo avergli versato mirra sul capo e averlo coronato di lana; quanto a noi, mirando al nostro utile, ci
terremmo un poeta e un mitologo più serio, ancorché meno gradevole, che sapesse imitare il modo di esprimersi
dell'uomo onesto e parlasse attenendosi ai modelli che abbiamo fissato all'inizio, quando abbiamo intrapreso a educare i
soldati».
«Faremmo senz'altro così », disse, «se dipendesse da noi».
«Ora, caro amico», ripresi, «è probabile che abbiamo trattato da cima a fondo l'aspetto della musica relativo alle narrazioni e ai miti: è stato stabilito ciò che si deve dire e come lo si deve dire». «Sembra anche a me», disse.
«E ora», domandai, «ci restano da trattare i generi del canto e delle melodie?» «è chiaro».
«Ma se vogliamo accordare il nostro discorso con le premesse, non sarebbe ormai facile per chiunque trovare le parole
adatte a spiegare come devono essere questi generi?» E Glaucone sorridendo disse: «Io, Socrate, rischio di rimanere fuori
da questo chiunque. Non sono in grado, almeno per ora, di comprendere di quali generi dobbiamo trattare; tuttavia posso
congetturarlo».
«Se non altro, però», ribattei, «sei in grado di asserire questo primo punto, ovvero che la melodia è composta di tre
elementi: la parola, l'armonia e il ritmo». «Sì », rispose, «questo sì ».
«Ma per quanto concerne la parola essa non differisce in nulla dalla semplice recitazione, poiché la si deve esprimere
nelle stesse forme e nelle stesse modalità che abbiamo fissato prima?» «è vero», disse.
«E l'armonia e il ritmo devono seguire la parola».
«Come no?» «Per la verità abbiamo detto che nei discorsi non c'è alcun bisogno di lamenti e gemiti».
«No di certo».
«Quali sono dunque le armonie lamentose? Dimmelo tu, che sei esperto di musica».
«La mixolidia, la sintonolidia e altre simili».(41) «Queste allora», chiesi, «si devono escludere? Sono inutili anche per
le donne che devono essere oneste, figurarsi per gli uomini!». «Giusto».
«Ma per i guardiani l'ubriachezza, la mollezza e la pigrizia sono più che mai disdicevoli».
«Come no?» «E quali sono le armonie molli e adatte ai simposi?» «Certe armonie ioniche e lidie», rispose, «che si
chiamano appunto rilassate».
«E tu, caro amico, potrai mai usarle con i guerrieri?» «Nient'affatto», rispose; «ma forse ti rimangono soltanto la
dorica e la frigia».
«Non conosco le armonie», dissi, «ma tu conserva quella che sappia imitare convenientemente la voce e gli accenti di
un uomo che dimostra coraggio in un'azione di guerra o in una qualsiasi opera violenta, e che anche quando non ha avuto
successo o va incontro alle ferite o alla morte o è caduto in altra disgrazia, in tutte queste circostanze lotta contro la sorte
con disciplina e fermezza; e conserva pure un'altra armonia, capace di imitare un uomo impegnato in un'azione pacifica
non per costrizione ma per sua volontà che cerca di persuadere un dio con la preghiera o un uomo con l'ammaestramento
e i consigli, o al contrario si mostra disponibile quando un altro lo prega o gli dà ammaestramenti o cerca di dissuaderlo, e
in virtù di questo ha ottenuto un risultato conforme ai suoi propositi e non ne va superbo, ma in tutte queste circostanze si comporta con temperanza ed equilibrio, accettando ciò che gli accade. Conserva queste due armonie, una violenta e l'altra volontaria, che sapranno imitare nel modo migliore le voci di persone sventurate, fortunate, temperanti, coraggiose». «Ma tu mi chiedi di conservare solo quelle che ho citato prima».
«Allora», ripresi, «nei canti e nelle melodie non avremo bisogno di molti suoni e di armonie complicate».
«Mi pare di no», disse.
«Perciò non manterremo costruttori di trigoni, di pectidi (42) e di tutti gli strumenti policordi e panarmonici».
«Evidentemente no».
«E i costruttori di flauti e i flautisti, li accoglierai nella città? Non è forse questo lo strumento più ricco di suoni, e gli
stessi strumenti panarmonici non sono un'imitazione del flauto?» «è chiaro», rispose.
«Allora», feci io, «come strumenti utili nella città ti rimangono la lira e la cetra, mentre nei campi i pastori avranno
una specie di zampogna».
«Così almeno ci porta a concludere il discorso», disse.
«D'altronde, caro amico», aggiunsi, «non facciamo nulla di strano se preferiamo Apollo e gli strumenti di Apollo a
Marsia e agli strumenti di Marsia».(43) «Non mi pare proprio, per Zeus!».
«Corpo d'un cane!»,(44) esclamai. «Senza rendercene conto stiamo di nuovo purgando la città che poc'anzi abbiamo
definito immersa nella mollezza!». «E in ciò operiamo da persone sagge», disse.
«Su», continuai «purghiamola anche del resto. La trattazione dei ritmi si conformerà a quella delle armonie: non
dovremo andare in cerca dei ritmi variegati e di metri d'ogni genere, ma considerare quali sono i ritmi di una vita ordinata
e coraggiosa; e una volta che li avremo individuati, costringere il piede e la melodia a seguire il modo di esprimersi
dettato da questa vita, anziché adattare la parola al piede e alla melodia. Quali poi siano questi ritmi, è compito tuo
indicarlo, come nel caso delle armonie».
«Ma per Zeus», obiettò, «non ne sono capace! Potrei dire, perché l'ho osservato, che i generi da cui si combinano i
metri sono tre, come nei suoni ce ne sono quattro da cui derivano tutte le melodie;(45) ma non so dire che tipo di
imitazioni siano, e di quale vita».
«Ma su questo», dissi, «ci consulteremo anche con Damone: (46) quali metri si addicono alla meschinità e
all'insolenza, o alla follia e ad altre manifestazioni di malvagità, e quali ritmi bisogna riservare ai sentimenti opposti.
Credo di averlo sentito parlare vagamente dell'enoplio, un certo metro composto, del dattilo e del verso eroico,(47) che lui
non so come ordinava con un'uguale ripartizione di arsi e tesi; e poi, mi sembra, faceva menzione di un giambo e di un
altro piede, il trocheo, ai quali adattava le lunghe e le brevi. E mi pare che per alcuni di questi metri criticasse o lodasse i movimenti del piede non meno dei ritmi stessi, o qualcosa di comune a entrambi, non lo so di preciso... ma queste cose,
come ho detto, rifiliamole a Damone, poiché distinguerle non è affare di poco conto. Non credi?» «Certo per Zeus!».
«Ma sei in grado di distinguere almeno questo, che la presenza e la mancanza di decoro si accompagnano alla
presenza e alla mancanza di ritmo?» «Come no?» «Ma la presenza e la mancanza di ritmo seguono, per somiglianza, l'una
lo stile bello, l'altra quello opposto, e lo stesso vale per l'armonia e la disarmonia, se il ritmo e l'armonia, come si diceva
prima, si regolano sulla parola e non viceversa».
«Certo», confermò, «sono loro che devono seguire la parola».
«E l'espressione e i vocaboli», domandai, «non seguono il carattere dell'anima?» «Come no?» «Mentre il resto
dipende dallo stile?» «Sì ».
«Quindi la scelta felice dei vocaboli, l'armonia, il decoro e il buon ritmo conseguono dalla semplicità, non quella che è
stoltezza ma noi addolciamo con questo eufemismo, ma quella disposizione d'animo contraddistinta da un carattere
veramente buono e nobile». «Senz'altro», disse.
«E non è forse questo che i giovani devono perseguire in ogni situazione, se vogliono adempiere il loro compito?»
«Sì , è questo». «Ma queste qualità informano anche la pittura e le altre arti simili, la tessitura, il ricamo, l'architettura e la
fabbricazione di ogni altra suppellettile, e inoltre la natura dei corpi e degli altri organismi; in tutto questo c'è decoro o
bruttezza. La mancanza di decoro, di ritmo e dì armonia è imparentata con la bassezza di linguaggio e di carattere, mentre
le qualità opposte sono sorelle e imitazioni dell'opposto, cioè di un carattere saggio e onesto». «Senza dubbio», disse.
«Dobbiamo dunque sorvegliare soltanto i poeti e costringerli a rappresentare nelle loro opere la bontà di carattere, o
altrimenti a non poetare presso di noi; oppure dobbiamo sorvegliare anche gli altri artefici e impedire loro di introdurre
ciò che è moralmente malvagio, sfrenato, ignobile e indecoroso sia nelle rappresentazioni di esseri viventi sia negli edifici
sia in ogni altro manufatto, o altrimenti non permettere di lavorare presso di noi a chi non sia capace di osservare questo
precetto, per evitare che i nostri guardiani, allevati tra immagini disoneste come tra le erbacce, cogliendone poco per volta
ogni giorno una grande quantità e pascendosene, accumulino senza avvedersene un unico grande male nella loro anima?
Non bisogna al contrario cercare quegli artefici che sappiano nobilmente seguire le tracce della natura di ciò che è bello e
decoroso, affinché i giovani, come chi abita in un luogo salubre, traggano vantaggio da qualunque parte un'impressione di
opere belle tocchi la loro vista o il loro udito, come un soffio di vento che porta buona salute da luoghi benefici, e sin
dalla fanciullezza li conduca senza che se accorgano alla conformità, all'amicizia e all'accordo con la retta ragione?»
«Questa», rispose, «sarebbe per loro l'educazione di gran lunga migliore».
«E l'educazione musicale, Glaucone», proseguii, «non è forse di estrema importanza per il fatto che il ritmo e
l'armonia penetrano nel più profondo dell'anima e vi si apprendono con la massima tenacia, conferendole decoro, e
infondono dignità in chi abbia ricevuto una corretta educazione, altrimenti producono l'effetto contrario? Chi è stato
educato a dovere in questo campo si accorgerà con grande acutezza di ciò che è difettoso e mal costruito oppure è
imperfetto per natura, e con giusta insofferenza loderà le cose belle e accogliendole con gioia nell'anima saprà nutrirsene
per diventare un uomo onesto, mentre biasimerà e detesterà a buon diritto le cose brutte sin da giovane, ancora prima di
poterne capire razionalmente il motivo; e una volta acquisita la ragione la saluterà con affetto, riconoscendo la sua grande
affinità con l'educazione ricevuta».
«Mi sembra», disse, «che l'educazione musicale abbia questo fine».
«Allo stesso modo», ripresi, «abbiamo acquisito una piena padronanza dell'alfabeto quando ci siamo resi conto che le
lettere sono poche e ricompaiono in tutte le parole esistenti, e non le abbiamo trascurate in nessuna combinazione, piccola
o grande che fosse, come se lì non occorresse individuarle, ma ci siamo sforzati di riconoscerle ovunque, perché solo così ,
e non prima, saremmo divenuti buoni conoscitori dell'alfabeto...» «è vero».
«Perciò anche le figure delle lettere, se mai apparissero nell'acqua o in uno specchio, non le distingueremo se non
conosciamo già le lettere stesse, anzi ciò fa parte della stessa arte e dello stesso studio?» «Senza dubbio».
«Allora, per gli dèi!, come dico di solito, non saremo esperti di musica, noi stessi e i guardiani che sosteniamo di
dover educare, se prima non riconosceremo gli aspetti della temperanza, del coraggio, della generosità, della magnanimità
e di tutte le virtù loro sorelle, come pure dei vizi a loro contrari che circolano ovunque, e non avvertiremo la loro presenza
e quella delle loro copie,(48) senza trascurarne alcuna, negli esseri in cui si trovano, piccoli o grandi che siano, nella
convinzione che facciano parte della stessa arte e dello stesso studio?» «è davvero necessario», rispose.
«Perciò», dissi, «quando capita che l'anima di un uomo sia fornita di nobili qualità morali e i tratti del suo aspetto
siano in accordo e in armonia con esse, in quanto partecipi della stessa impronta, sarà lo spettacolo più bello che si possa
contemplare?» «E come!» «E quanto più una cosa è bella, tanto più è amabile?» «Come no?» «Allora il musico potrebbe
innamorarsi solo di chi presenta queste doti nella forma più alta, non di chi è privo di armonia».
«No», rispose, «almeno se il difetto fosse nell'anima; se invece fosse nel corpo, lo sopporterebbe, tanto da
acconsentire ad amarlo». «Capisco», feci io, «che ami o hai amato una persona così , e te lo concedo. Ma dimmi questo: la temperanza ha qualcosa in comune con un piacere eccessivo?» «E come può averlo», rispose, «se questo porta fuori di senno non meno del dolore?» «E con qualche altra virtù?» «Assolutamente no!».
«E con l'insolenza e la sfrenatezza?» «Più di tutto!».
«Sai dirmi un piacere maggiore e più acuto di quello amoroso?» «No, e neanche uno più folle».
«Il giusto amore invece è la naturale inclinazione ad amare ciò che è ordinato e bello secondo la temperanza e
l'armonia della musica?» «Certamente», rispose.
«Quindi al giusto amore non bisogna accostare nulla che sia folle o affine alla sfrenatezza?» «No, non bisogna».
«Questo piacere va pertanto escluso e non deve avere relazione alcuna con un amante e un amato che si amino
davvero?» «Ma certo, per Zeus!», rispose. «Dobbiamo escluderlo, Socrate!».
«A quanto pare, dunque, nella città da noi fondata stabilirai per legge che l'amante baci l'amato, stia con lui e lo tocchi
come un figlio, per un nobile fine e con il suo consenso, ma quanto al resto si comporti con la persona a lui cara in modo
tale da non dare mai l'impressione che si spinga con lui troppo oltre questi limiti, altrimenti dovrà sostenere il biasimo di
uomo ignorante di musica e inesperto del bello».
«Proprio così », disse.
«Ma non sembra anche a te», chiesi, «che il nostro discorso sulla musica sia giunto alla conclusione? Esso è terminato
proprio là dove deve terminare: la musica trova il suo compimento nell'amore del bello».
«Sono d'accordo», rispose.
«Dopo la musica i giovani vanno educati nella ginnastica». «Naturalmente».
«Anche in questa disciplina devono essere educati accuratamente sin da fanciulli, e per tutta la vita. Secondo me le
cose stanno pressappoco così : ma considera anche tu la questione. Non mi pare che il corpo, per quanto vigoroso, renda
buona l'anima con la sua virtù, ma che al contrario sia l'anima buona a mettere il corpo nella migliore condizione possibile
grazie alla propria virtù. Che cosa ne pensi?» «Anche a me pare che sia così », rispose.
«Quindi agiremmo bene, se dopo aver rivolto sufficienti cure alla mente le affidassimo il compito di esaminare con
precisione ciò che riguarda il corpo, indicandole soltanto delle norme generali per non fare lunghi discorsi?» «Senza
dubbio».
«Abbiamo detto che i guardiani devono astenersi dall'ubriachezza, perché a chiunque più che a un guardiano è
concesso di ubriacarsi e di non sapere dove si trova».
«Già, perché sarebbe ridicolo che un guardiano avesse bisogno di un guardiano!», esclamò.
«E che dire del vitto? I nostri uomini sono come atleti che devono affrontare la gara più dura. O no?» «Sì ».
«E il regime di questi sportivi può essere adatto a loro?» «Forse».
«Eppure», dissi, «induce sonnolenza ed è dannoso alla salute.
Non vedi che questi campioni passano la vita a dormire e, se escono solo un poco dalla dieta prescritta, si ammalano
gravemente?» «Lo vedo».
«Perciò», continuai, «occorre un allenamento più accurato per gli atleti della guerra, che per forza di cose devono
vegliare come cani, avere vista e udito quanto mai acuti e non essere cagionevoli di salute, poiché nelle operazioni militari
cambiano spesso acqua e cibo e passano dalle calure estive ai rigori invernali».
«Mi pare di sì ».
«E la migliore ginnastica non sarà in certo qual modo sorella della musica semplice che abbiamo trattato poco fa?»
«Cosa vuoi dire?» «Voglio dire una ginnastica semplice ed equilibrata, soprattutto quella che prepara alla guerra».
«In che senso?» «Questo lo si può apprendere anche da Omero», risposi. «Tu sai che nei banchetti di guerra egli non
fa mangiare ai suoi eroi pesce, benché si trovino vicini al mare, sull'Ellesponto, né carni bollite, ma solo carni arrostite,
perché sono quelle più facili da preparare per i soldati; in poche parole, dovunque è più comodo usare il fuoco che portare
in giro dei recipienti». Certo».
«Inoltre mi pare che Omero non abbia mai menzionato neanche i condimenti. E non lo sanno anche gli altri atleti che
chi vuole godere d'una buona salute fisica deve astenersi da tutto ciò?» «Lo sanno bene», rispose, «e giustamente ne
astengono! ».
«A quanto pare, caro amico, non apprezzi la tavola siracusana e la varietà di leccornie siciliane,(49) se queste
prescrizioni ti sembrano giuste». «Io no».
«Allora disapprovi anche che una ragazza di Corinto (50) sia amante di chi vuole godere di una buona salute fisica».
«Senza dubbio».
«Quindi anche le rinomate delizie dei dolci attici?» «Per forza».
«Potremmo ben paragonare, credo, una tale alimentazione e un tale regime di vita alla composizione musicale e al
canto che comprende ogni genere di armonia e di ritmo».
«Come no?» «Dunque la varietà produce in quel caso la sfrenatezza, in questo la malattia, mentre la semplicità genera
nella musica la temperanza dell'anima, nella ginnastica la sanità del corpo?» «Verissimo», rispose.
«Ma se in una città si diffondono la sfrenatezza e le malattie, non si aprono forse molti tribunali e ambulatori, e non
sono tenute in onore l'arte giudiziaria e quella medica, quando molti uomini liberi si dedicano a queste attività con
passione?» «E come!».
«Ma quale prova maggiore dell'educazione cattiva e disonorevole nella città potrai addurre del fatto che necessitino di
medici e giudici eccellenti non solo le persone dappoco e i lavoratori manuali, ma anche coloro che si danno l'aria di aver ricevuto un'educazione liberale? Non ti sembra una grave e vergognosa prova di incultura l'essere costretti a ricorrere a
una giustizia presa a prestito da altri, in qualità di padroni e giudici, per la mancapza di una propria?» «è la massima
vergogna!», esclamò.
«Ma non ti sembra ancora più vergognoso», incalzai, «quando uno non solo trascorre la maggior parte della vita nei
tribunali a sostenere e intentare processi, ma è persino indotto dal cattivo gusto a vantarsi della propria abilità nel
commettere ingiustizie e della propria capacità di attuare ogni sorta di raggiro, di trovare con destrezza ogni scappatoia e
di cavarsela in modo da restare impunito, e questo per sciocchezze di nessun valore, ignorando quanto sia più bello e più
onesto regolare la propria vita in modo tale da non aver bisogno di un giudice sonnacchioso?»
«Certo», rispose, «questo è ancora più vergognoso».
«E ricorrere alla medicina», continuai, «non solo per ferite o per certe malattie che si ripetono ogni anno, ma anche
perché, a causa della pigrizia e del regime di vita che abbiamo descritto, ci si riempie di umori e vapori come le paludi, e
costringere i dotti Asclepiadi (51) a dare alle malattie i nomi di flatulenze e catarri, non ti sembra vergognoso?» «E
come!», rispose. «Questi nomi di malattie sono davvero nuovi e strani».
«Ma non esistevano», dissi, «al tempo di Asclepio, credo! Lo arguisco dal fatto che a Troia, quando Euripilo fu ferito,
i suoi figli non trovarono nulla da ridire alla donna che gli diede da bere vino di Pramno cosparso di molta farina e
formaggio grattato, una medicina che mi sembra infiammatoria, né rimproverarono Patroclo per la sua cura».(52) «In
effetti», disse, «è una pozione strana per chi è in quelle condizioni!».
«No», replicai, «se consideri che la medicina d'oggi, educatrice delle malattie, a quanto dicono non era praticata dagli
Asclepiadi prima che nascesse Erodico.(53) Questi era un allenatore che, ammalatosi, mescolò la ginnastica alla medicina
e dapprima tormentò soprattutto se stesso, in seguito molti altri». «In che modo?», chiese.
«Prolungando la propria morte», risposi. «Benché seguisse attentamente il decorso della sua malattia mortale non
riuscì , credo, a guarirne, ma passò la vita a curarsi mettendo da parte ogni altro interesse e tormentandosi per ogni minima trasgressione al suo consueto regime, e grazie alla sua abilità giunse mezzo morto alla vecchiaia».
«Ha riportato davvero un bel premio per la sua arte!», esclamò.
«Quello che si addice», ripresi, «a chi ignora che Asclepio non rivelò ai suoi discendenti questo aspetto della medicina
non per ignoranza o per inesperienza, ma perché sapeva che in ogni città governata con buone leggi a ciascuno è
assegnato un compito da eseguire, e nessuno ha tempo libero per stare malato e curarsi tutta una vita. Ed è ridicolo che
noi facciamo caso a questo comportamento negli artigiani, ma non lo avvertiamo in quelli che danno l'impressione di
essere ricchi e felici».
«In che senso. », domandò.
«Un falegname», spiegai, «quando si ammala, chiede al medico di dargli una pozione per vomitare fuori la malattia,
oppure di guarirlo con una purga o con una cauterizzazione o con un'incisione; se però gli viene prescritta una cura lunga,
che prevede berretti di lana in testa e cose del genere, dice subito che non ha tempo per essere malato e non gli serve
vivere badando alla sua malattia e trascurando il lavoro che lo attende. Dopo di che manda tanti saluti a un medico simile
e ritorna al regime di vita consueto, riacquista la salute e vive praticando il suo mestiere; se invece il suo corpo non è in
grado di reggere, si libera dei suoi affanni con la morte».
«A un uomo del genere», disse, «sembra proprio confacente questo utilizzo della medicina».
«Ma non è forse perché aveva un lavoro da svolgere, e se non lo avesse fatto non gli sarebbe servito continuare a
vivere?» «è evidente», rispose.
«Mentre il ricco, diciamo, non ha per le mani un lavoro tale, che non gli consente di vivere se è costretto a starne
lontano?» «Così almeno si dice».
«Allora», proseguii, «non ascolti le parole di Focilide: quando si ha di che vivere, si deve esercitare la virtù».(54)
«Bisogna farlo anche prima, penso», osservò.
«Non stiamo a contendere con lui su questo punto», ripresi, «ma chiariamo a noi stessi se il ricco deve praticare la
virtù e non può vivere qualora non la pratichi, o se la cura delle malattie impedisce di attendere all'arte del falegname e
alle altre arti, ma non di seguire l'ammonimento di Focilide».
«Sì , per Zeus!», esclamò. «E di solito l'ostacolo maggiore è questa cura superflua del corpo che va ben oltre la
ginnastica: infatti è incompatibile con l'amministrazione della casa, la vita militare e le cariche sedentarie all'interno della
città».
«Ma la cosa più grave è che essa ostacola qualsiasi studio, riflessione e meditazione interiore, poiché è sempre in
allarme per mal di testa e vertigini e giudica la filosofia responsabile del loro manifestarsi; pertanto è d'impaccio ovunque
si pratichi e si tenga in pregio la virtù, dal momento che induce a credere di stare sempre male e a non smettere mai di
lamentarsi della propria condizione fisica». «è naturale», disse.
«Dobbiamo quindi affermare che anche Asclepio, ben consapevole di ciò, insegnò la medicina a coloro che per natura
e regime di vita godevano di buona costituzione fisica ed erano malati in una sola parte del corpo, e pur scacciando le
malattie con farmaci e incisioni prescrisse loro la consueta regola di vita per non arrecare danno alla società; ma per
quanto riguarda i corpi affetti da malattie profonde e diffuse, non tentò di curarli con regimi di graduale evacuazione e
infusione, rendendo l'esistenza di un uomo lunga e penosa e facendogli generare figli, com'è ovvio, tali e quali a lui, ma
ritenne di non dover curare chi non riuscisse a vivere per il tempo stabilito, in quanto inutile a se stesso e alla città?»
«Tu», disse, «fai di Asclepio un uomo politico!».
«è chiaro», risposi. «Ed essendo tale, non vedi che anche i suoi figli a Troia si rivelarono valorosi in guerra e fecero
della medicina l'uso che dico io? Non ricordi che anche a Menelao, dalla ferita inferta da Paride, "succhiarono il sangue e
leni farmaci sparsero sopra",(55) ma non prescrissero a lui più che a Euripilo cosa dovesse mangiare o bere in seguito,
poiché quei farmaci potevano guarire uomini che prima di essere feriti erano sani e avevano un regime di vita ordinato,
anche se qualche volta toccava loro bere il ciceone;(56) viceversa ritenevano che la vita di persone malaticce e sregolate
non fosse utile né a loro né agli altri, e che per costoro l'arte medica non dovesse esistere e non si dovesse curare neanche se fossero stati più ricchi di Mida».(57) «Li fai davvero accorti, i figli di Asclepio! », esclamò.
«Ed è il caso di pensarlo», risposi, «sebbene i poeti tragici e Pindaro, in disaccordo con noi, asseriscano che Asclepio
era figlio di Apollo, ma per denaro fu spinto a guarire un uomo ricco già moribondo e di conseguenza fu colpito dalla
folgore.(58) Noi però, in base a quanto detto prima, non crederemo a queste due loro affermazioni, ma sosterremo che se
era figlio di un dio non era turpemente avido di guadagno, se invece era turpemente avido di guadagno non era figlio di
un dio».
«Più che giusto», ammise. «Ma che cosa dici a questo proposito, Socrate? Non occorre forse avere buoni medici nella
città? E tali saranno appunto coloro che hanno trattato moltissimi pazienti sani e moltissimi malati, così come i giudici
migliori saranno quelli che hanno avuto a che fare con individui d'ogni sorta».
«Certo», risposi, «parlo dei buoni medici. Ma tu sai quali sono, secondo me?» «Dimmelo tu», rispose.
«Ci proverò», dissi. «Ma tu hai messo assieme nella stessa domanda problemi tra loro differenti».
«In che senso?», chiese.
«I medici», spiegai, «diventerebbero molto bravi se a partire dall'infanzia, oltre che imparare l'arte, avessero pratica
del maggior numero possibile di corpi guasti, e patissero essi stessi malattie d'ogni tipo e non fossero per natura del tutto
sani. Infatti non curano, penso, il corpo con il corpo, altrimenti non potrebbero mai essere malati o diventarlo; ma lo
curano con l'anima, alla quale non è dato di curar bene se diventa malata o è già malata». «Giusto», disse.
«Invece un giudice, caro amico, governa l'anima con l'anima. E non è ammissibile che la sua anima sia stata educata sin dalla giovinezza tra anime malvagie e le abbia frequentate, né che sia passata attraverso ogni sorta di ingiustizia, così da arguire con acutezza le colpe altrui dalle proprie, come accade per le malattie del corpo; ma durante la sua giovinezza dev'essere rimasta inesperta e immune dalle cattive abitudini, se deve distinguere il giusto in base alla propria onestà. Per questo i giovani onesti appaiono sempliciotti e facilmente ingannabili dagli ingiusti, perché non hanno dentro di sé esempi di passioni analoghe a quelle che agitano i malvagi».
«In effetti», disse, «a loro capita proprio questo».
«Ecco perché», continuai, «il buon giudice non dev'essere un giovane, ma un vecchio che ha imparato tardi che cos'è
l'ingiustizia, senza averla sentita presente nell'anima come un qualcosa di proprio, e che solo dopo un lungo periodo di
tempo arriva a comprendere la sua natura di male per averla studiata negli altri come un vizio a lui estraneo, grazie alla
scienza acquisita e non per esperienza personale».
«Un giudice simile», disse, «sembra davvero molto nobile».
«E anche buono, come tu chiedevi», ripresi: «chi infatti ha un'anima buona è buono. Al contrario, l'uomo scaltro e
sospettoso del male, colui che ha commesso molte ingiustizie e crede di essere smaliziato e abile, quando ha a che fare
con i suoi simili appare bravo a stare in guardia, perché si basa sui modelli che ha dentro di sé; quando invece incontra
persone oneste e più anziane si rivela uno sciocco, perché diffida a sproposito e ignora la sanità di costumi, di cui non
possiede modelli. Ma dal momento che si imbatte più spesso in persone malvagie che in persone dabbene, dà a se stesso e agli altri l'impressione di essere più sapiente che ignorante». «Proprio così », disse.
«Perciò», continuai, «non è questo il giudice buono e saggio che dobbiamo cercare, ma quello di prima: la malvagità
non potrà mai conoscere la virtù e se stessa, la virtù invece, se la natura viene educata, col tempo acquisterà conoscenza di se stessa e della malvagità. Costui dunque, non il malvagio, diventa a mio parere accorto».
«Sembra anche a me», disse.
«Pertanto stabilirai per legge nella città una medicina e un'arte giudiziaria nelle forme che abbiamo descritto, in
maniera che curino soltanto i cittadini validi nel corpo e nell'anima e, quanto agli altri, i medici lascino morire coloro che
presentano difetti fisici, i giudici sopprimano coloro che sono guasti e incurabili nell'anima?» «Sì », rispose, «questa è la
soluzione migliore per gli stessi sofferenti e per la città».
«Ed è chiaro», dissi, «che i giovani si guarderanno bene dalla necessità di ricorrere all'arte giudiziaria, praticando solo
quella musica semplice che abbiamo definito generatrice di temperanza».
«Ma certo!», esclamò.
«E il musicista che pratica la ginnastica seguendo le stesse orme non giungerà, se lo vuole, a non aver bisogno alcuno
della medicina, salvo in caso di necessità?» «Mi pare di sì ».
«E compirà i faticosi esercizi ginnici mirando a risvegliare la parte animosa della propria indole più che la forza fisica,
a differenza degli altri atleti, che mangiano e faticano per acquistare vigore».
«Giustissimo», disse.
«Dunque, Glaucone», proseguii, «anche coloro che stabiliscono di educare con la musica e con la ginnastica non lo fanno per il motivo che credono alcuni, cioè per curare con l'una il corpo e con l'altra l'anima?» «E perché allora?»,
domandò. «Probabilmente», risposi, «essi le pongono entrambe soprattutto al servizio dell'anima».
«E perché?» «Non noti», dissi, «quale disposizione d'animo acquisisce chi pratica per tutta la vita la ginnastica senza
accostarsì alla musica, o chi viceversa si trova nella condizione opposta?» «Di che cosa stai parlando?», chiese.
«Della rozzezza e della durezza da un lato, della mollezza e della mansuetudine dall'altro», risposi.
«Certo», disse. «Coloro che di dedicano alla pura ginnastica riescono rozzi più del dovuto, coloro che invece praticano
solo la musica diventano troppo molli».
«Tuttavia», aggiunsi, «la rozzezza potrebbe derivare dall'animosità di carattere, e una corretta educazione potrebbe
trasformarla in coraggio, ma se venisse tesa più del dovuto diventerebbe, com'è ovvio, durezza e intrattabilità».
«Mi pare di sì », disse.
«Quindi l'indole filosofica non possiederebbe la dote della mitezza, e se fosse troppo rilassata si volgerebbe in
eccessiva mollezza, mentre una buona educazione può renderla mite e ben regolata?» «è così ».
«Perciò diciamo che i guardiani devono possedere entrambe le nature».
«Devono, certo».
«Ed esse devono essere ben armonizzate tra loro?» «Come no?» «E l'anima di chi è ben armonizzato è temperante e
coraggiosa?» «Senz'altro».
«E quella di chi non è ben armonizzato è vile e selvatica?» «E come!».
«Pertanto, quando uno permette alla musica di ammaliarlo col flauto e di versargli dalle orecchie, come da un imbuto,
nell'anima le armonie che poco fa chiamavamo dolci, molli e lamentose, e passa tutta la vita a gorgheggiare e a gustare le
delizie del canto, in un primo momento, se c'era in lui un che di animoso, si ammollisce come il ferro e da inutile e duro
diventa utile; in seguito però, se persiste in questo piacere e prosegue l'incanto, si strugge e si liquefà fino a consumare la
sua energia e a tagliare, per così dire, i nervi dell'anima, diventando un "molle guerriero"».(59) «Senza dubbio», disse.
«E se uno», continuai, «ha già in partenza un'indole non animosa, giunse rapidamente a questa condizione; se invece è
animoso, indebolisce il suo ardore e lo rende facilmente eccitabile, pronto ad accendersi e a spegnersi per cose da nulla.
Così da animoso diventa irritabile e iracondo, pieno di scontrosità». «Certamente».
«E se uno si dedica assiduamente alla ginnastica fino a satollarsene, senza accostarsi alla musica e alla filosofia? In un
primo momento, data la sua robusta costituzione fisica, non si riempie di orgoglio e di ardore, superando in coraggio
anche se stesso?» «E come!».
«Ma che cosa accade se non fa nient'altro e non ha alcun contatto con le Muse? Anche se nella sua anima vi fosse un
qualche desiderio di apprendere, dal momento che non gusta alcuna nozione o ricerca e non partecipa di un ragionamento
o di qualche forma di musica, quest'elemento non diventa debole, sordo e cieco, non essendo tenuto desto, né nutrito, né
purificato dalle sue sensazioni?» «è così », rispose.
«Un uomo simile, penso, diventa nemico dei ragionamenti e delle Muse, e nei discorsi non fa più uso della
persuasione, ma in ogni circostanza raggiunge il suo scopo con la violenza e la rozzezza come una belva e vive in una
stolida ignoranza priva di compostezza e di grazia». «è proprio così », disse.
«Posso quindi affermare che, a quanto sembra, la divinità ha concesso agli uomini due arti, la musica e la ginnastica,
per questi due elementi, l'animosità e la filosofia, e solo in via accessoria per l'anima e per il corpo, proprio allo scopo che
quegli elementi si armonizzassero tra loro tendendosi e allentandosi fino alla giusta misura». «Pare di sì », disse.
«Chi dunque fonde nel modo migliore musica e ginnastica e le applica all'anima nel modo più equilibrato, diremo a
ragione che è il più perfetto esperto di musica e di armonia, molto più di chi accorda uno strumento».
«è naturale, Socrate», disse.
«Allora, Glaucone, anche nella nostra città avremo sempre bisogno di un tale soprintendente, se intendiamo
salvaguardare la costituzione?» «Certo, ne avremo il massimo bisogno!».
«Questi dunque saranno i modelli della cultura e dell'educazione.
A che scopo dovremmo passare in rassegna le danze, le battute di caccia con o senza cani, le gare ginniche e ippiche
dei nostri cittadini? In pratica è chiaro che tali attività devono conformarsi ai princì pi che abbiamo stabilito, e scoprirli
non è più difficile». «Forse no», disse.
«Bene», conclusi. «E adesso che cosa ci resterà da determinare? Forse chi governerà e chi sarà governato?» «Ma
certo!». «Non è forse chiaro che i governanti devono essere anziani e i sudditi giovani?» «è chiaro».
«E che devono essere i migliori tra loro?» «è chiaro anche questo».
«Ma i contadini migliori non sono forse quelli più portati per l'agricoltura?» «Sì ».
«Ora, se i governanti devono essere i migliori tra i guardiani, non occorre che siano anche i più idonei a custodire la
città?» «Sì ». «E per assolvere questo compito devono essere intelligenti e capaci e ipoltre devono preoccuparsi del bene della città?» «è così ».
«Ma ci si prende cura soprattutto di ciò che si ha caro». «è inevitabile».
«E si ha caro soprattutto ciò il cui interesse si ritiene identico al proprio, e il cui successo si crede coincida con il
proprio successo, e viceversa». «è così », disse.
«Perciò bisogna scegliere tra i guardiani uomini tali che al nostro esame risultino estremamente decisi a compiere per
tutta la vita col massimo zelo ciò che ritengono utile alla città e si rifiutino in ogni modo di compiere ciò che ritengono
dannoso». «Sì », disse, «questi sono uomini adatti».
«Mi sembra quindi che li si debba sorvegliare a ogni età, per vedere se custodiscono questa regola e nessun
incantamento o costrizione li induce a ripudiare e dimenticare il principio secondo il quale si deve fare ciò che è meglio
per la città». «Di quale ripudio parli?», domandò.
«Te lo spiegherò», risposi. «Mi sembra che un'opinione esca dall'animo volontariamente o involontariamente, nel
primo caso quando si muta un'opinione falsa, nel secondo caso ogni qual volta si tratta di un'opinione vera».
«Capisco la questione della volontarietà», disse, «ma devo comprendere quella dell'involontarietà».
«Ma come? Non pensi anche tu», domandai, «che gli uomini si privino involontariamente dei beni e volontariamente
dei mali? Non è forse un male ingannarsi sulla verità, e un bene essere nel vero? E non ti sembra che essere nel vero
significhi avere opinioni conformi alla realtà?» «Hai ragione», rispose, «e mi sembra che gli uomini non si privino
volontariamente di un'opinione vera».
«E non capita loro questo perché vengono derubati, raggirati o costretti con la forza?» «Non capisco neanche ora»,
rispose. «Forse parlo in uno stile troppo elevato», dissi. «Per derubati intendo quelli che si lasciano convincere a cambiare
opinione e quelli che se la dimenticano, perché agli uni la sottrae di nascosto il tempo, agli altri la ragione. Mi capisci
ora?» «Sì ».
«Per costretti con la forza intendo quelli indotti a cambiare opinione da un dolore o una sofferenza».
«Ho capito anche questo», disse, «e hai ragione».
«Per raggirati anche tu intenderesti, penso, quelli che cambiano opinione perché sono stati ammaliati dal piacere o
hanno paura di qualcosa».
«Sì », disse «tutto ciò che inganna sembra sprigionare una malì a».
«Come ho appena detto, bisogna cercare quali sono i migliori custodi di quello che è il loro principio, ossia fare
sempre ciò che ritengono sia il meglio per la città. Bisogna quindi osservarli sin da fanciulli, proponendo loro soprattutto
compiti in cui questo principio può essere dimenticato ed eluso, e chi ha buona memoria e non si lascia facilmente
ingannare dev'essere scelto, gli altri vanno scartati. O no?» «Sì ».
«E bisogna sottoporli a fatiche, sofferenze e prove, in cui osservare proprio queste caratteristiche». «Giusto», disse.
«Allora», continuai, «devono sostenere una lotta con un terzo genere d'inganno, quello della malì a, e vanno studiati
come quando si guidano i puledri nella direzione da cui provengono rumori e grida, per vedere se si fanno prendere dalla
paura; allo stesso modo bisogna condurre i guardiani ancora giovani ad assistere a eventi spaventevoli e poi gettarli in
preda ai piaceri, saggiandoli molto di più che l'oro col fuoco, per vedere se non si lasciano facilmente ammaliare,
mantengono il decoro in ogni occasione e sono buoni custodi di se stessi e della musica che hanno imparato, mostrandosi
in tutte queste circostanze dotati di ritmo e di armonia, e in virtù di queste qualità possono essere molti utili a se stessi e
alla città. Chi esce indenne dalle prove cui viene via via sottoposto da bambino, da ragazzo e da adulto dev'essere messo a
capo e a guardia della città e onorato sia da vivo sia da morto, ottenendo i più alti privilegi della tomba e degli altri
monumenti; chi invece non risponde a questi requisiti dev'essere scartato. Più o meno questo, Glaucone», conclusi, «mi
pare il criterio opportuno per scegliere e istituire i governanti e i guardiani, sia pure espresso in linea generale, non in
maniera dettagliata».
«Anch'io la penso grosso modo così », disse.
«E non sarebbe davvero la cosa più corretta definire questi ultimi perfetti guardiani dai nemici esterni e dagli amici
interni, affinché gli uni non vogliano, gli altri non possano fare del male, e considerare i giovani che finora chiamavamo
guardiani difensori e ausiliari delle deliberazioni prese dai governanti?» «Mi sembra di sì », rispose.
«Con quale mezzo potremmo allora far credere una genuina menzogna, di quelle che s'inventano al momento
opportuno e di cui parlavamo prima, soprattutto ai governanti stessi, o altrimenti al resto della città?» «Quale
menzogna?», chiese.
«Nulla di nuovo», risposi, «solo una storia fenicia,(60) già accaduta in passato in molti luoghi, come ci dicono in
modo convincente i poeti; ma non so se sia accaduta o possa mai accadere ai giorni nostri, e del resto richiede una buona
dose di persuasione per essere convincente».
«Sembra che tu esiti a raccontarla», osservò.
«Quando l'avrò raccontata», replicai, «la mia esitazione ti sembrerà ragionevole».
«Parla pure», disse, «non avere paura».
«Allora parlerò, per quanto non sappia con che coraggio e con quali parole; e cercherò di persuadere innanzitutto i governanti stessi e i soldati, poi anche il resto della città, che essi avevano l'impressione di ricevere tutta l'educazione
fisica e spirituale impartita da noi come in un sogno che accadesse attorno a loro, ma in realtà in quel momento erano
plasmati ed educati nel seno della terra, essi, le loro armi e il resto del loro equipaggiamento già bell'è fabbricato; e
quando furono interamente formati la terra, che era la loro madre, li portò alla luce. Per questo ora devono provvedere alla
terra in cui vivono e difenderla come loro madre e nutrice, se qualcuno muove contro di essa, e considerare gli altri
cittadini come fratelli nati anch'essi dalla terra».
«Non a torto», esclamò, «prima ti vergognavi a proferire questa menzogna!».
«E ne avevo ben donde!», risposi. «Tuttavia ascolta anche il resto del mito. Voi cittadini siete tutti fratelli, diremo loro
continuando il racconto, ma la divinità, plasmandovi, al momento della nascita ha infuso dell'oro in quanti di voi sono atti
a governare, e perciò essi hanno il pregio più alto; negli ausiliari ha infuso dell'argento, nei contadini e negli altri artigiani
del ferro e del bronzo. Dal momento che siete tutti d'una stessa stirpe, di solito potete generare figli simili a voi, ma in
certi casi dall'oro può nascere una prole d'argento e dall'argento una discendenza d'oro, e così via da un metallo all'altro.
Ai governanti quindi la divinità impone, come primo e più importante precetto, di non custodire e non sorvegliare
nessuno così attentamente come i propri figli, per scoprire quale metallo sia stato mescolato alle loro anime; e se il loro
rampollo nasce misto di bronzo o di ferro, dovranno respingerlo senza alcuna pietà tra gli artigiani o i contadini,
assegnandogli il rango che compete alla sua natura. Se invece da costoro nascerà un figlio con una vena d'oro o d'argento, dovranno ricompensarlo sollevandolo al rango di guardiano o di aiutante, perché secondo un oracolo la città andrà in rovina quando la custodirà un guardiano di ferro o di bronzo. Conosci dunque un qualche sistema per convincerli di questo mito?» «Per convincere loro», disse, «assolutamente no; semmai per convincere i loro figli e discendenti e la
posterità in generale».
«Ma anche questo», dissi, «potrebbe essere un buon sistema per indurli a curarsi maggiormente della città e dei
rapporti reciproci; capisco grosso modo il tuo pensiero. L'esito di questo progetto dipenderà da come lo diffonderà la
fama; per quanto sta in noi, armiamo questi figli della terra e conduciamoli innanzi, sotto la guida dei governanti. Una
volta arrivati, osservino il punto della città più favorevole per accamparsi, quello da cui potrebbero dominare meglio sugli
abitanti, se qualcuno non volesse obbedire alle leggi, e respingere i nemici esterni, se uno di loro piombasse come un lupo
su gregge; dopo essersi accampati e aver compiuto i sacrifici dovuti, preparino le tende. O no?» «Sì », rispose.
«Ed esse non dovranno essere in grado di proteggerli dal freddo e dal caldo?» «Come no?», rispose. «Mi sembra
infatti che tu stia parlando delle abitazioni».
«Sì », confermai, «ma abitazioni di soldati, non di commercianti».
«E che differenza c'è tra loro, secondo te?», chiese.
«Cercherò di spiegartelo», risposi. «La colpa più grave e più vergognosa per dei pastori sarebbe quella di allevare dei
cani da guardia del gregge in modo tale che per l'intemperanza, la fame o qualche altra cattiva abitudine tentassero essi
stessi di assalire le pecore, diventando, anziché cani, simili ai lupi».
«Sì », disse, «sarebbe grave: come negarlo?» «Non bisogna quindi evitare in ogni modo che i nostri difensori facciano
una cosa del genere con i cittadini, dal momento che sono più forti di loro, e da alleati benevoli si trasformino in padroni
crudeli?» «Bisogna evitarlo», rispose.
«E per loro la massima precauzione non consisterebbe nell'essere realmente educati bene?» «Ma in effetti lo sono»,
ribatté.
Allora io dissi: «Non vale la pena di insistere su questo, caro Glaucone, bensì sul principio che abbiamo enunciato
prima: essi devono ricevere la giusta educazione, qualunque sia, se si vuole che abbiano la massima disposizione alla
mitezza verso se stessi e verso le persone che custodiscono».
«è giusto», concordò.
«Perciò una persona assennata direbbe che, oltre a questa educazione, bisogna fornire loro anche le abitazioni e un
patrimonio tale che non li distolga dall'impegno di essere i migliori guardiani possibile e non li spinga a fare del male agli
altri cittadini». «E dirà il vero».
«Vedi dunque», proseguii, «se per avere questi requisiti essi debbano attenersi, nel modo di vivere e di abitare, ai
seguenti precetti.(61) Innanzitutto nessuno possieda sostanze proprie, se non quelle strettamente necessarie; in secondo
luogo nessuno abbia un'abitazione e una dispensa in cui non possa entrare chiunque lo desideri.
Quanto al sostentamento di cui necessitano atleti della guerra temperanti e coraggiosi, in base a un accordo con gli
altri cittadini ricevano un compenso per il servizio di guardiani che non sia né superiore né inferiore al loro fabbisogno
annuale. Vivano in comune partecipando ai banchetti pubblici come se fossero all'accampamento. Occorre poi dire loro che da sempre hanno nell'anima oro e argento divino, dono degli dèi, e non necessitano affatto di quello umano; quindi è
un'empietà contaminare quel possesso mescolandolo all'acquisto di oro mortale, perché molte azioni empie sono state
compiute per la moneta del volgo, mentre quella che portano dentro di loro è pura. Anzi, essi siano gli unici, tra tutti i
cittadini, a cui non sia lecito maneggiare e toccare oro e argento, né entrare in una casa che lo contenga, né portarlo al
collo, né bere da boccali d'argento o d'oro.
Così potranno restare incolumi e salvare la città. Ma quando possederanno terra, case e moneta propria, e diventeranno
amministratori e contadini anziché guardiani, padroni ostili anziché alleati degli altri cittadini, passeranno tutta la vita a
odiare e ad essere odiati, a tendere insidie e ad essere insidiati, e avranno molta più paura dei nemici interni che di quelli
esterni, correndo ormai sull'orlo della rovina, essi e il resto della città. In considerazione di tutto ciò», conclusi,
«dobbiamo dire che questa dev'essere la condizione dei guardiani per quanto riguarda l'abitazione e le altre necessità, e
questo dobbiamo stabilire per legge, oppure no?» «Senz'altro», rispose Glaucone.
NOTE:
- 1) Omero, Odyssea, libro 11, versi 489-491 (parla l'ombra di Achille, rivoita a Odisseo).
- 2) Omero, Ilias, libro 20, versi 64-65.
- 3) Ivi, libro 23, versi 103-104 (parla Achille, che ha tentato invano di abbracciare l'ombra di Patroclo apparsagli in sogno).
- 4) Omero, Odyssea, libro 10, verso 495, il verso allude all'indovino Tiresia, che anche dopo la morte conservò parte della sua fisicità.
- 5) Omero, Ilias, libro 16, versi 856-857.
- 6) Ivi, libro 23, versi 100-101.
- 7) Omero, Odyssea, libro 24, versi 6-9: i versi si riferiscono alle anime dei Proci che, accompagnate da Ermes, scendono nell'Ade.
- 8) Fiumi infernali.
- 9) Il passo presenta una corruzione insanabile; la traduzione non tiene conto di "os oietai", che non dà alcun senso nel contesto.
- 10) Omero, Ilias, libro 24, versi 10-12. La citazione è fedele solo nella prima metà, ma la parte parafrasata è chiaramente corrotta.
- 11) Ivi, libro 23, versi 22-24. Questo passo, come il precedente si riferisce al dolore di Achille per la morte di Patroclo.
- 12) Ivi, libro 22, versi 414-415. Il passo si riferisce allo strazio di Priamo che ha appena assistito alla morte di Ettore.
- 13) Omero, Ilias, libro 18, verso 54.
- 14) Ivi, libro 22, versi 168-169. Con queste parole Zeus si rammarica di veder Ettore inseguito da Achille, presagendone la prossima fine.
- 15) Ivi, libro 16, versi 433-434, Zeus piange la morte del figlio Sarpedone.
- 16) Ivi, libro 1, versi 599-600.
- 17) Omero, Odyssea, libro 17, versi 383-384.
- 18) Omero, Ilias, libro 4, verso 412.
- 19) Ivi, libro 3, verso 8 e libro 4, verso 431, accostati nel contesto platonico.
- 20) Ivi, libro 1, verso 225. Sono insulti che Achille irato rivolge ad Agamennone.
- 21) Omero, Odyssea, libro 9, versi 8-10. Sono parole di Ulisse.
- 22) Ivi, libro 12, verso 342.
- 23) Omero, Ilias, libro 14, verso 296.
- 24) Cfr. Omero, Odyssea, libro 8, verso 266 e seguenti.
- 25) Ivi, libro 20, versi 17-18. Ulisse rivolge queste parole a se stesso prima di affrontare i Proci.
- 26) Il verso, forse appartenente a un'opera perduta di Esiodo, è riecheggiato da Euripide, Medea 964.
- 27) Cfr. Omero, Ilias, libro 9, versi 515-518; libro 19, versi 278-281; libro 24 passim. Il cadavere è quello di Ettore, riscattato a caro prezzo da Priamo.
- 28) Ivi, libro 22, versi 15-20.
- 29) Ivi, libro 21, verso 211 e seguenti. Lo Scamandro, fiume che scorreva vicino a Troia, pregò inutilmente Achille di non ostruirgli il corso coi cadaveri dei nemici uccisi; allora si gonfiò e costrinse l'eroe greco a una fuga precipitosa.
- 30) Ivi, libro 22, verso 151. Lo Spercheo è un fiume della Grecia settentrionale.
- 31) Cfr. ivi, libro 24, versi 14-18 e libro 23, versi 175-176.
- 32) Peleo era figlio di Eaco, giudice degli Inferi e figlio a sua volta di Zeus; il centauro Chirone fu precettore di
- Achille e di altri eroi come Eracle e Giasone.
- 33) Teseo e Piritoo rapirono Elena e tentarono di rapire Persefone dall'Ade.
- 34) Eschilo, frammento 162 Radt. Sono versi tratti dalla Niobe, tragedia perduta, e si riferiscono a Tantalo e ai suoi discendenti.
- 35) Omero, Ilias, libro 1, versi 115-116.
- 36) Parafrasi di Omero, Ilias, libro 1, versi 22-42.
- 37) Il ditirambo era una forma lirica corale legato al culto di Dioniso, che ebbe una parte importante nella nascita della tragedia. Dopo aver toccato l'apice con Pindaro e Bacchilide, ai tempi di Platone era in piena decadenza.
- 38) Allusione ad alcune vicende mitologiche rappresentate nelle tragedie, come quelle di Niobe, che si vantava della sua numerosa prole, e di Semele, incinta di Dioniso per opera di Zeus.
- 39) La traduzione accoglie la lezione "aplé", proposta da Adam in luogo del tràdito "alle", che non dà senso plausibile.
- 40) Probabile riferimento ad alcune macchine di scena che nelle rappresentazioni teatrali potevano riprodurre il rumore dei tuono e del fulmine.
- 41) Nella musica greca quattro erano le armonie pricipali: la dorica, la frigia, la lidia e la ionica. Queste potevano però combinarsi tra loro e dare origine ad altre melodie secondarie, come quelle menzionate da Glaucone. Il discorso di Platone testimonia la rilevanza sociale della musica nel mondo greco e in effetti è tutto incentrato sulla connessione tra musica ed etica.
- 42) Due strumenti a corda simili all'arpa.
- 43) Un satiro che con il flauto sfidò in una gara musicale Apollo, il cui strumento era la lira; Apollo lo vinse e lo scorticò vivo. Il flauto era considerato meno nobile della lira e degli strumenti a corda in generale, poiché, essendo associato al culto di Dioniso e di Cibele, si pensava che il suo suono portasse a un perturbamento dell'animo; la vicenda di Marsia è la trasposizione mitica di questa credenza. Nal libro 5 Platone bandisce esplicitamente il flauto dalla città ideale.
- 44) Esclamazione caratteristica di Socrate; cfr. libro 8; libro 9; Phaedrus 228b.
- 45) Al primo genere di metri appartengono dattilo, anapesto e spondeo; al secondo peone, cretico e baccheo; al terzo il trocheo e il giambo. Non è invece sicuro cosa s'intenda per i quattro generi di suoni: se le quattro note di un tetracordo, o le quattro armonie principali, o gli intervalli musicali di quarta, quinta, ottava e doppia ottava.
- 46) Un musicista ateniese attivo nel quinto secolo a.C., maestro di Pericle, Socrate e Nicia.
- 47) L'enoplio è un ritmo di marcia militare variamente composto. Con «verso eroico» si allude probabilmente all'esametro, ma il tono del passo è volutamente vago per meglio riflettere la dichiarata incompetenza di Socrate in materia.
- 48) Sono le virtù e i vizi che i poeti e gli artisti riproducono nelle loro opere, desumendoli dalla realtà sensibile.
- 49) La cucina siciliana, e quella siracusana in particolare, era molto rinomata.
- 50) Corinto aveva la fama, ben meritata, di essere la "capitale del vizio" della Grecia antica.
- 51) I medici, discepoli di Asclepio, dio della medicina.
- 52) I figli di Asclepio, Macaone e Podalirio, parteciparono alla guerra di Troia in qualità di medici dell'esercito acheo. Nella citazione i due episodi omerici sono notevolmente alterati: la pozione preparata da Ecamede, concubina di Nestore, era per lo stesso Macaone, ferito in uno scontro (Omero, Ilias, libro 11, verso 624 e seguenti); Euripilo fu invece curato da Patroclo con una radice tritata ivi, libro 11, versi 844-847; cfr. anche libro 15, versi 392-394). Il primo episodio è correttamente ricordato da Platone, Ion 538b.
- 53) Erodico di Megara, divenuto poi cittadino di Selimbria, associò alla medicina la dietetica e l'esercizio fisico, imponendosi un regime di vita eccessivamente rigoroso. Cfr. anche Platone, Protagoras 316e; Phaedrus 227d.
- 54) Parafrasi di Focilide, frammento 9 Gentili-Prato. Poeta elegiaco del sesto secolo a.C., Focilide continuò la tradizione esiodea della poesia gnomica. Di lui restano pochi frammenti.
- 55) Omero, Ilias, libro 4, verso 218, con qualche variante rispetto al nostro testo.
- 56) Mistura di acqua, vino, miele, cacio grattato, farina d'orzo e altri ingredienti, usata come bevanda ristoratrice dagli eroi omerici.
- 57) Mida era il leggendario re frigio che chiese e ottenne da Dioniso di poter trasformare in oro tutto ciò che toccava, ma la sua avidità si ritorse contro di lui, poiché anche tutto ciò che voleva mangiare e bere diventava oro; perciò, per non morire di fame, dovette pregare il dio di liberarlo da questo dono funesto. La sua ricchezza era in Grecia proverbiale.
- 58) Cfr. Eschilo, Agamemnon 1022-1024; Euripide, Alcestis 3-4; Pindaro, Pythia in 55-58. Secondo la versione tradizionale del mito, Asclepio fu punito da Zeus per aver richiamato in vita uno o più eroi morti: le fonti oscillano tra Ippolito, Capaneo, Licurgo, Tindareo. La variante platonica è funzionale al motivo della corruzione, presente già in Pindaro.
- 59) Così è detto Menelao in Omero, Ilias, libro 17, verso 588.
- 60) è una storia «fenicia» probabilmente perché riecheggia il mito del fenicio Cadmo, che generò i futuri cittadini di Tebe città di cui egli stesso divenne re, seminando denti di serpente; non è però escluso che Platone alluda anche alla proverbiale mendacità dei Fenici.
- 61) Le prescrizioni elencate di seguito, come quella precedente in merito all'eliminazione dei neonati deboli o minorati, sono in buona parte dedotte dalle usanze spartane; non a caso la costituzione di Sparta sarà indicata nel libro 8 come la migliore tra quelle vigenti.